DALLA PREISTORIA ALLA TARDA ANTICHITA', GLI OCCHI SONO STATI UN MEZZO ESPRESSIVO FONDAMENTALE CHE TRASCENDE LA MANIFESTAZIONE DI EMOZIONI E SENTIMENTI, CONFLUENDO NELLO SPAZIO DELLA CHIAROVEGGENZA, DELL'UNIONE MISTICA E DELL'EVOCAZIONE DELLE FORZE DIVINE.
IMMAGINE: dettaglio dell'Auriga di Delfi", statua greca in bronzo, datata 475 a.C., alta 184 centimetri. Gli occhi sono di pietre dure, incastonati; le ciglia sono di rame. Nell'antichità le incastonature degli occhi potevano essere di vetro o minerali come corniola e lapislazzuli. La tecnica degli occhi incastonati per le statue risale all'Epoca Neolitica.
"L'occhio non vedrebbe mai il sole se non fosse già simile al sole, né un'anima vedrebbe il bello se non fosse bella". (Plotino, 203-270 d.C.)
PREMESSA
Nell'iconografia arcaica delle più importanti civiltà del mondo e nei manufatti delle culture tradizionali, alle immagini sacre è associato uno sguardo fisso e sbarrato nella maggior parte dei casi, ed una stilizzazione spiraliforme degli occhi per ciò che riguarda entrambe le polarità ultramondane, siano esse infere o celestiali. La SPIRALE indica un'irresistibile forza di emanazione o di rapimento estatico, che può essere intesa con valore positivo (costruttivo, creativo, ascendente) o negativo (distruttivo, esiziale, discendente). Per questo motivo spesso le divinità, in molte antiche civiltà e nelle culture tradizionali, vengono raffigurate con occhi a spirale e ciò vale per il dio del sole (civiltà MAYA) come per le entità degli Inferi. L'equivalente degli occhi a spirale sono gli sguardi fissi ed estatici delle raffigurazioni sacre, secondo un canone diffuso in tutto il mondo. Le troviamo presso i SUMERI nelle famose 12 statuette di adoranti dai grandi occhi blu circolari, in alabastro, del TEMPIO DI ESHNUNNA (2.900-2350 a.C., alte dai 21 ai 72 cm., Tardo Periodo Dinastico); nei GIGANTI DI MONTE PRAMA: sculture di pietra risalenti alla CIVILTA' NURAGICA, alte dai 2 ai 2 metri e mezzo, datate circa 1.300 a.C.; nelle sculture del dio del sole della civiltà MAYA, KINICH-AHAU, dagli occhi a volte spiraliformi, a volte circolari ed enormi; nei MOAI dell'Isola di Pasqua (o RAPA NUI): statue alte dai 3 (la più piccola) fino a 10 metri (la maggiore) in basalto disposte sulle colline dell'isola, realizzate dal 1250 al 1500 d.C., alcune delle quali recano ancora incastonati gli occhi di corallo bianco. Questo modello appartiene soprattutto all'arte arcaica, ma anche nelle raffigurazioni tardo-antiche bizantine troviamo la particolare attenzione dedicata allo sguardo, come nella testa colossale di COSTANTINO IL GRANDE, in marmo, alta 260 cm., datata 313-324 d.C., dove l'Imperatore è rappresentato con occhi spalancati più grandi del naturale. Una variante dello sguardo sbarrato ed estatico sono gli occhi spiraliformi, che fungono da rafforzativo all'idea del sovrumano, nel tentativo di infondere all'osservatore un titanico stupore, avvicinando la sua immaginazione alla potenza dell'esperienza liminale in un'immersione verso l'ignoto. L'immagine della SPIRALE crea un'attrazione irresistibile. Lo sguardo della divinità nelle raffigurazioni è, infatti, il mezzo più potente dell'iniziazione inconscia verso un percorso teso all'amplificazione della coscienza; come, all'inverso, nell'esempio delle divinità abissali, di una discesa introspettiva fino agli spazi più tenebrosi dell'anima, allo scopo di affrontare gli ostacoli alla propria piena realizzazione come esseri umani; gli occhi a spirale con cui vengono rappresentate molte divinità infernali esortano, appunto, l'osservatore ad intraprendere il viaggio agli Inferi, ossia la morte iniziatica come prefigurazione della morte fisica, il cui superamento permette l'acquisizione di più profonde capacità percettive; a questo riguardo si potrebbe disquisire a lungo sul doppio valore di ogni simbolo o archetipo. Gli occhi a spirale delle divinità celestiali nelle raffigurazioni di molte antiche civiltà, al contrario, esprimono un flusso emanativo di energia creativa ed invitano all'elevazione interiore.
IMMAGINE: raffigurazione del dio della pioggia, Tlaloc, in giadeite verde, civiltà Mixteca. Altezza: 24 centimetri. Datazione: 900 d.C. Gli occhi della divinità sono spiraliformi, le braccia incrociate sul petto sono un gesto universale di conciliazione degli opposti, in questo caso dal favore dell'abbondanza che il dio elargisce alla terra. (Throckmorton Fine Art, New York)
Immagine: le 14 statuette di adoranti dai grandi occhi blu circolari, in alabastro, del TEMPIO DI ESHNUNNA (2.900-2350 a.C., alte dai 21 ai 72 cm. Civiltà Sumera, Tardo Periodo Dinastico)IMMAGINE: testa di una delle 28 statue di pietra dette Giganti di Monte Prama, civiltà Nuragica, Sardegna, alte dai 2 ai 2 metri e mezzo, datate circa 1.300 a.C. Rappresentano 16 pugili, 5 arcieri e 5 guerrieri. (Museo Civico Giovanni Marongiu)
L'OCCHIO DESTRO DI ODINO
Nella MITOLOGIA NORRENA, ODINO, dio supremo della guerra, della poesia e dell'ispirazione, aveva un solo occhio e questa era la caratteristica che lo contraddistingueva. ODINO venne informato dell'esistenza del POZZO DI MIMIR, nelle cui profondità era nascosta la fonte di ogni conoscenza e si mise in viaggio per raggiungere questo luogo e berne l'acqua, ma quando arrivò incontrò il guardiano del pozzo, lo stesso MIMIR, un gigante celebre per la sua saggezza, il quale, per poter soddisfare la sete di conoscenza di ODINO, richiese il sacrificio di un suo occhio. ODINO acconsentì, perse l'occhio destro e bevve alla fonte raccogliendo l'acqua in un corno, divenendo così conoscitore di tutti i segreti dell'universo, ossia delle dinamiche invisibili che governano il mondo percepibile ai sensi. L'OCCHIO DESTRO è connesso alla vista diurna e quindi alla mente razionale, all'espansione orizzontale della coscienza. L'OCCHIO SINISTRO, al contrario, offre la visione profonda e trascendente, permettendo la percezione della realtà nascosta dietro i veli del mondo tangibile che governa il destino di ogni cosa. La cecità dell'OCCHIO DESTRO indica pertanto il sacrificio necessario alla conoscenza più profonda, perchè è l'espansione orizzontale stessa, legata alla realtà ordinaria e alla sfera razionale, che si ritira nell'impossibilità di comunicare l'essenza intima delle cose, la monade come nucleo spirituale della manifestazione. Fisiologicamente, superare la soglia della realtà tangibile e guardare oltre la barriera dell'illusione fisica risalendo alla fonte causale del tutto, è equiparabile alla vista diretta del sole che rende momentaneamente ciechi se di brevissima durata, fino a causare danni permanenti agli occhi se protratta più a lungo. Per poter acquisire la percezione della trama profonda del cosmo, l'uomo deve rinunciare alla propria precedente condizione riduttiva e razionale, potenziando simbolicamente la visione notturna dell'OCCHIO SINISTRO per comprendere le cause invisibili, le forze che sottendono tutto ciò che accade e ciò che esiste nell'universo percepibile con i cinque sensi. Per osservare in profondità, è necessario appannare e, in qualche modo, dissolvere momentaneamente la visione di superficie, e la manifestazione di superficie non è altro che la conseguenza di movimenti metafisici, così come le immagini di un televisore provengono da impulsi elettromagntici invisibili trasmessi nell'atmosfera.
L'OCCHIO PERDUTO DI HORUS
Nella MITOLOGIA EGIZIA, al contrario, nello scontro con lo zio SETH (dio del caos) per vendicare l'uccisione di suo padre OSIRIDE (dio della vegetazione e dell'oltretomba), HORUS (dio dei cieli) perde l'OCCHIO SINISTRO, ossia la facoltà di vedere oltre il velo della realtà ordinaria; dopo essere stato sconfitto, SETH restituì l'occhio a HORUS, ma questo era rotto in sei parti; l'OCCHIO DI HORUS venne in seguito recuperato dal dio della conoscenza THOT che lo ricompose e, non trovandone la sesta parte, la sostituì con una sostanza divina. Oltre al significato di primato dell'intelligenza e della conoscenza (HORUS) sulle forze del caos (SETH), l'OCCHIO DI HORUS è una rappresentazione simbolica delle unità frazionarie in relazione ai cinque sensi, come spiega l'egittologa Maria Carmela Betrò (Comitato Scientifico della Fondazione Museo Egizio di Torino):
"La parte verso il naso rappresenta la frazione 1⁄2 e l'olfatto (il naso); la pupilla raffigura la frazione 1⁄4 e la vista (la luce); al sopracciglio sta la frazione 1⁄8 e il pensiero (la mente); la parte verso l'orecchio ritrae la frazione 1⁄16 e l'udito (l'orecchio); la frazione 1⁄32 e il gusto (il germoglio del frumento) sono nella coda curva ; il piede incarna la frazione 1⁄64 e il tatto (il piede che tocca terra)". Sommando le varie parti si ha un totale di 63⁄64: si riteneva che il restante 1⁄64 fosse stato aggiunto dal dio Thot, sotto forma di poteri magici". (Maria Carmela Betrò, "Geroglifici", pagina 55, 1995)
L'OCCHIO SINISTRO PERDUTO DI NEFERTITI
Riguardo l'ANTICO EGITTO, pullulano le ipotesi più disparate sull'assenza dell'OCCHIO SINISTRO nel famoso ritratto della regina NEFERTITI, in pietra calcarea, alto 50 cm, datato 1345 a.C. (XVIII dinastia); secondo alcuni si tratta di un manufatto di laboratorio, usato come campione per insegnare agli allievi scultori; l'ipotesi (a mio avviso) più credibile è quella secondo la quale l'occhio mancante (che doveva essere, come l'altro, in pasta vitrea) sia caduto e andato perso, ma c'è chi suppone si tratti di un'elusione voluta, in riferimento ad un significato spirituale. In tal caso, l'occhi mancante è quello sinistro, ossia l'occhio lunare di HORUS, connesso alla percezione trascendente, mentre l'OCCHIO DESTRO era equiparato al sole. Frequentemente gli EGIZI indicavano l'occhio sinistro come "OCCHIO DI HORUS" e quello destro come "OCCHIO DI RA". Dato che NEFERTITI era la regina moglie di AKHENATON (il faraone "eretico" promotore del culto solare di ATON) e che la riforma amarniana determinò un capovolgimento di prospettiva nella nuova visione religiosa e mistica del suo regno, si può teorizzare che la mancanza dell'OCCHIO SINISTRO indichi l'iniziazione della regina al nuovo culto del dio unico solare ATON, un culto che fino a quel momento era appannaggio segreto di un'elite aristocratica e che AKHENATON rese universale. Mentre prima rituali e cerimonie venivano celebrati in luoghi bui e segreti, inaccessibili ai profani, ATON veniva onorato all'aria aperta, in piena luce e non necessitava di pratiche occulte, appunto perchè aveva l'ardire di manifestare apertamente la presenza divina. Ma questo cosa c'entra con l'occhio sinistro mancante della regina NEFERTITI? Può significare (sempre qualora si tratti di una scelta deliberata dell'artista) che l'OCCHIO SINISTRO LUNARE di NEFERTITI sia stato sacrificato in favore dell'OCCHIO DESTRO SOLARE? A questo punto si potrebbe supporre che la regina fosse priva di spiritualità (occhio sinistro lunare), ma se si tiene presente la logica inversa del culto di ATON rispetto alle tradizioni precedenti, ecco che tutto si assesta: il potere introspettivo, trascendente e percettivo dell'OCCHIO SINISTRO è stato trasferito all'OCCHIO DESTRO, ossia nella sfera della realtà terrena, orizzontale e sensibile, in quanto il culto di ATON fu una rivelazione, un "trasferimento", precisamente; la mente intuitiva assorbì la mente razionale di superficie e i due piani, femminile-maschile, divennero uno.
L'OCCHIO DESTRO CIECO DELLA SCIAMANA DI DOLNI VESTONICE
Volgendo lo sguardo al nostro passato più remoto giungiamo fino a 26.000 anni fa, presso l'accampamento paleolitico vicino al comune di DOLNI VESTONICE, Moravia, Repubblica Ceca. In questo sito, accanto ad un forno di cottura, sono state scoperte migliaia di statuette di animali in terracotta in miniatura, di fattura eccellente. Accanto a questo forno, all'interno dell'abitazione-laboratorio, lo scheletro di una donna che, con ogni probabilità, era la ceramista del villaggio, ma anche una sciamana. Fra gli altri manufatti venne scoperta una TESTA-RITRATTO in miniatura, in avorio di mammuth, alta 4,8 cm., che gli studiosi indentificano come lo stesso ritratto dell'artista-sciamana; porta un'acconciatura a chignon e il suo volto ha tratti delicati e gracili, corrispondenti alle fattezze del cranio e allo scheletro della donna. Il particolare più importante, riguardo all'argomento che stiamo trattando, di questa immagine è l'OCCHIO DESTRO volutamente deformato: il sinistro è accuratamente delineato, il destro appare più grande, forse per evidenziare la cavità dell'orbita dell'occhio mancante (dobbiamo tenere presente le piccolissime dmensioni del manufatto e la corrosione del tempo). Il tema dell'occhio deformato è presente in molte maschere del PALEOLITICO SUPERIORE (come quella di LASCAUX, di EL JUYO, di ENTREFOCES, ecc...) e si protrae nel simbolismo iniziatico di ogni periodo storico fino ai giorni nostri; generalmente rappresenta il sacrificio di una parte di sè per il raggiungimento di un'essenza e una visione superiore. Nel caso della ceramista di DOLNI VESTONICE è probabile che si trattasse di un personaggio avvolto da un alone di solennità e autorevolezza nell'ambito della comunità. La notevole distanza della capanna-laboratorio dal resto del villaggio indica una necessità di tranquillità e raccoglimento nell'esistenza di quest'artista eccezionale, i cui lavori denotano uno stile unico e a tratti fantastico nella resa delle raffigurazioni faunistiche.
"Paleolitico Superiore - le immagini svelate":
https://alessia-birri.blogspot.com/2022/09/paleolitico-superiore-le-immagini.html
IMMAGINE: un altro esempio di occhio mancante o deformato lo vediamo in una delle 4 maschere nel percorso più profondo della caverna di Altamira, Spagna, Paleolitico Superiore; datazione: 15.000 anni; misure: 17 centimetri. La caverna è famosa per le sue oltre 900 raffigurazioni di bisonti, cavalli, cervi, cinghiali, ecc..., dipinte con ocra rossa e contorni neri. Le maschere sono costituite da conformazioni naturali della roccia dalle vaghe sembianze di un volto umano o animale, evidenziato da tratti a carboncino.LO SGUARDO PIETRIFICANTE DI MEDUSA
Le tre GORGONI della MITOLOGIA GRECA erano STENO, EURIALE e MEDUSA, figlie di FORCO (antica divinità marina, ibrido uomo-serpente) e CETO (divinità femminile delle acque); le tre sorelle avevano il potere di pietrificare chiunque con lo sguardo, anche i più grandi eroi. Il nome "MEDUSA" significa "guardiana" o "protettrice", dal greco "médo" (proteggere). EURIALE deriva da "eurys": grande, vasto. STENO è associata alla forza ("steno": comprimere). Da qui si comprende la loro natura di triade psicologica e spirituale. Delle tre sorelle MEDUSA era l'unica ad avere natura mortale ma la sua bellezza competeva con quella di ATENA. Quando MEDUSA venne sedotta da POSEIDONE nello stesso tempio di ATENA di cui era sacerdotessa-guardiana, ATENA gelosa, per vendicarsi, trasformò i suoi bellissimi capelli in una chioma di serpenti, dalla sua bocca spuntarono zanne suine. Naturalmente, sarebbe stato più difficile per ATENA vendicarsi contro POSEIDONE, che era un dio, ma la natura mortale di MEDUSA la rese vittima prescelta. MEDUSA, nonostante la sua trasformazione mostruosa, non perse la facoltà divina di pietrificare coloro che avessero incrociato il suo sguardo; assieme alle altre due sorelle, venne relegata su un'isola ai confini dell'oceano occidentale. In seguito MEDUSA verrà decapitata da PERSEO secondo una promessa fatta al re di Serifo, POLIDETTE, il quale gli giurò che, se gli avesse recato la testa della GORGONE, non avrebbe più preteso la mano di sua madre DANAE. POLIDETTE sperava che l'impresa di PERSEO fallisse, ma quest'ultimo si procurò la testa decapitata di MEDUSA come promesso e, mostrandola al Re, lo trasformò in una statua di pietra. Ma senza l'aiuto della dea ATENA, che gli donò uno scudo di bronzo che fungeva da specchio in cui l'immagine di MEDUSA venne riflessa, PERSEO non avrebbe mai potuto sconfiggere la GORGONE. Narra OVIDIO nelle METAMORFOSI:
"Medusa era di una bellezza meravigliosa, e fu desiderata e contesa da molti pretendenti, e in tutta la sua persona nulla era più splendido dei suoi capelli".
L'immagine della dea associata ai serpenti ha origini antichissime e le prime testimonianze risalgono all'epoca neolitica. Le GORGONI appartenevano ad un pantheon di divinità femminili arcaiche, associate all'archetipo della GRANDE MADRE preistorica, mentre ATENA, le cui prime testimonianze risalgono all'ETA' DEL BRONZO, assume un'importanza fondamentale nella GRECIA CLASSICA, rispecchiando lo spirito dell'epoca in quanto dea dell'intelligenza razionale, del controllo, della giustizia e di tutti gli attributi concernenti la misura e l'equilibrio. Le GORGONI, al contrario, compresa MEDUSA, esprimevano le forze ctonie, gli aspetti incontrollabili della natura; MEDUSA, che fra le altre due sorelle mostruose (STENO e EURIALE, infatti, avevano sempre avuto chiome di serpenti) era quella che si distingueva per il meraviglioso aspetto, probabilmente discendeva dalle dee neolitiche domatrici di belve e serpenti, "dee-guardiane" appunto, in grado di tenere a bada le forze selvagge della natura e della psiche e perciò punita da ATENA con la trasformazione dei suoi bellissimi capelli in un groviglio di viscidi serpenti, dato che non fu in grado di proteggere il tempio della dea. Quindi abbiamo la dea minoica (raffigurata nelle due statuette scoperte presso il PALAZZO DI MINOSSE a CNOSSO dall'archeologo britannico ARTHUR EVANS nel 1903) come "guardiana" dei serpenti che stringe fra le mani da un lato, dall'altro MEDUSA con gli stessi serpenti sul capo che, al contrario, rappresentano la sua incapacità di controllare (e, quindi, di custodire) lo stesso tempio di ATENA di cui era sacerdotessa. MEDUSA rappresenta perciò un lato psicologico della stessa ATENA, ossia quello più vulnerabile ed emotivo, che non fu in grado di reagire alla prepotenza di POSEIDONE lasciando che quest'ultimo, possedendola, profanasse il tempio (e quindi il corpo) della stessa ATENA; da qui la "vendetta" della dea classica che con la sua punizione relega e reprime l'aspetto più primordiale della psiche (incarnato da MEDUSA). Questo mito indica anche il passaggio dall'ETA' ARCAICA all'EPOCA CLASSICA della filosofia, della logica e della critica razionale. Il discorso sulla pietrificazione causata dallo sguardo di MEDUSA ci riporta a numerosi altri esempi mitologici, come il celebre episodio biblico della MOGLIE DI LOT; una leggenda tirolese narra di come la regina dei giganti, crudele ed egoista, sia stata trasformata nella vetta FRAU-HITT della catena montuosa Nordkette in AUSTRIA, dopo essere stata maledetta da una mendicante a cui aveva offerto una pietra al posto del pane; in SARDEGNA il folklore ci tramanda la storia di EFIS e EFISINA, un frate e una suora pietrificati causa del loro amore e trasformati in un masso, nel MONTE RUJU, dalle vaghe sembianze umane; nella mitologia norrena SVARTALFAR è un elfo con il potere della pietrificazione, paragonato alle GORGONI greche; nell'agiografia cristiana di SANTA BARBARA un pastore che aiutò la santa a fuggire dall'inseguimento del padre infuriato per la nuova fede della figlia fu trasformato in pietra; una tradizione aborigena narra di come tre sorelle si innamorarono di tre uomini della tribù DHARRUK, ma siccome il matrimonio era impossibile a causa della legge tribale, vennero trasformate in vette rocciose, le BLUE MOUNTAINS (Australia), e si potrebbe continuare a lungo su questo argomento, seguendo un filo conduttore simbolico che si espande a miti e racconti di ogni continente. La pietrificazione è solitamente causata dallo sguardo delle divinità o dei personaggi che detengono particolari poteri. Possiamo trovare un importante spunto in questo brano dell'esoterista spagnolo EDOUARDO CIRLOT (1916-1973):
<< Il mito di DEUCALIONE che trasforma pietre in uomini e le litofanie hanno la loro opposizione nelle leggende della "pietrificazione". Come è facile intuire, si tratta degli aspetti contrari e particolari dei movimenti opposti dell'evoluzione e dell'involuzione. Pietrificare è trattenere, rinchiudere. Si diceva che la GORGONE MEDUSA trasformasse con lo sguardo gli uomini in pietre. Molti racconti del folklore e molte leggende medioevali parlano di simili pietrificazioni o incantesimi. Le fiabe, talvolta, invece che addormentare i personaggi (si tratta del medesimo simbolo) li pietrificano, trasformandoli in statue. In "LA BELLA E LA BESTIA" le due sorelle cattive della protagonista si tramutano in statue. Le parole che l'autore mette in bocca alla fata chiariscono il significato del simbolo: "Diventate due statue, ma conservate la ragione sotto la pietra che vi racchiude. Rimarrete davanti alla porta del palazzo di vostra sorella e il castigo che vi infliggo non è altro che quello di essere testimoni della sua felicità. Non potrete tornare alle vostre sembianze primitive che nel momento in cui riconoscerete i vostri errori".
La pietrificazione è, quindi, l'arresto del progresso morale, l'arresto dell'evoluzione e, nel caso che non si precipiti nell'abisso, quantomeno, trattiene.
E' il caso della moglie di Lot (Genesi 19,26) e il pericolo che incombe continuamente su Ulisse nella sua peregrinazione durante il ritorno a Itaca, simbolo della pietra celeste, dell'esistenza assunta per l'eternità >>. (Brano da "Il libro dei simboli", Jean Edouardo Cirlot, pag.346-347 alla voce "Pietrificazione")
Ne deriva che, secondo il paradigma greco, le divinità connesse agli antichi culti, come MEDUSA, le GORGONI, ma anche i loro genitori FORCO e CETO e molte altre, fossero concepite come elementi statici, emotivi e ostacolanti sul cammino evolutivo, mentre il potere della dea classica, ATENA, consisteva nella ricerca razionale dell'equilibrio e della misura in tutte le cose; l'essenza di questo pensiero innovatore trapela nell'architettura e nell'arte della GRECIA CLASSICA, nella ricerca dell'armonia e dell'imitazione della natura. Di questo argomento ho trattato anche nel saggio "Il mito universale dei gemelli divini" riguardo a PROMETEO. Ma nelle raffigurazioni della testa di MEDUSA più recenti d'epoca romana, fra il groviglio di serpi compaiono due ali, a indicare il potere trasmutativo racchiuso nell'energia intrappolata, tenuta prigioniera dalla legione dei rettili. La dea ATENA, inoltre, dopo la sua decapitazione da parte di PERSEO, pose l'immagine di MEDUSA al centro del suo scudo: questo significa che l'energia della sua parte emozionale (MEDUSA) viene tenuta sotto controllo e indirizzata dalla mente speculativa e dalla conoscenza (ATENA). Il giovane eroe PERSEO è simbolo si energia adolescenziale, di leggerezza e coraggio connessi a quest'età di passaggio, perciò viene raffigurato con le ali ai piedi e sulla testa (vedi la statua di BENVENUTO CELLINI), mentre MEDUSA rappresenta l'immobilità e la rigidità di un'anima progioniera. Ma se PERSEO ha le ali sulla testa, anche MEDUSA le possiede e, infatti, dal sangue caduto a terra dopo la sua uccisione nacque PEGASO, il cavallo alato, uno degli archetipi fondamentali dell'anima che supera i legami della materialità. Proprio come suggerito nel brano di CIRLOT, la nostra esistenza è costellata di soste, di "distrazioni" dal nostro autentico percorso: passioni, infatuazioni, falsi desideri, ossessioni, manie che non sono altro che riflessi esteriori di esigenze interiori trascurate; nel brano si fa riferimento al viaggio di ULISSE e ai molti incantesimi (o illusioni) di cui fu vittima l'eroe nel suo ritorno a ITACA (l'isola dei LOTOFAGI, la MAGA CIRCE, la dea CALIPSO, il canto delle SIRENE, ecc...), e questi incantesimi e i loro personaggi non sono altro che rappresentazioni di "forze" esterne che rendono succube l'anima indirizzando le energie dell'uomo ai loro scopi. PENELOPE, come incarnazione dell'anima di ULISSE, rimane prigioniera e vittima degli intrusi finchè la coscienza di ULISSE, risvegliata, non abbandona le vane e deleterie illusioni del mondo per ricongiungersi a lei. Ma ogni eroe leggendario che si rispetti, prima di giungere alla meta e alla vittoria sulle forze oscure, deve attraversare una fase di "pietrificazione" durante la quale poteri intrusivi dominano le sue azioni o le sue brame, l'importante è che, di volta in volta, il protagonista riesca sempre a risvegliarsi non permettendo all'entità intrusiva di fondersi a lui, fino ad un affrancamento in età matura da tutti gli inganni della mente. Ora, osservando bene la realtà che ci circonda, ci possiamo accorgere di come l'uomo comune, nella maggior parte dei casi, nasca e muoia senza mai essersi affrancato da queste monadi bramose di espansione e sempre a caccia di alberghi; lo vediamo continuamente nelle persone che incontriamo dopo vent'anni e scopriamo sempre uguali, sempre le stesse idee fisse, sempre le stesse abitudini, sempre le stesse tendenze, come se il tempo non fosse nemmeno passato, in una vera e propria inconsapevole "pietrificazione" interiore, incapaci di distogliere lo sguardo dagli occhi di MEDUSA. Infatti, ULISSE si meravigliò di sè stesso dopo aver saputo che erano tracorsi ben sette anni nel suo soggiorno sull'isola di CALIPSO, un lasso di tempo che egli nemmeno percepì preso com'era nei lacci dell'incantesimo della dea (i serpenti di MEDUSA possono essere visti anche come lacci, come legami). La gravità non consiste nel cadere nei tranelli, ma nell'inabissarsi a tal punto (come ben spiegato nel brano di CIRLOT qui sopra) da non avere più la forza di riemergere, abbandonando perciò sè stessi ad influssi inferiori e, nel peggiore dei casi, incorporandoli in una vera e propria fusione eterica. Tutte le volte che cerchiamo qualcosa fuori di noi desideriamo il falso, la copia imperfetta e illusoria di ciò che dev'essere sviluppato nell'interiorità; la manifestazione più banale di ciò è l'innamoramento, mitologicamente rappresentato dal dardo di CUPIDO: una forza esterna, preposta alla perpetuazione della specie, devia l'attenzione dell'uomo (o della donna) verso un soggetto che è "altro da sè" e che rimpiazza l'autentica e innata ricerca del divino e della completezza interiore.
Un'interpretazione più popolare propone l'immagine di MEDUSA come soggetto apotropaico, con potere respingente nei confronti del male che, in questo modo, si rifletterebbe come davanti ad uno specchio divenendo inoffensivo.
IMMAGINE: antefissa (elemento architettonico usato nell'antichità come motivo ornamentale lungo la fascia perimetrale del tetto) con testa di Medusa. Provenienza: rinvenimento spontaneo nei pressi di Taranto (Puglia). Altezza: 18 centimetri. Datazione: 500 a.C. Diversamente dall'immagine analizzata sopra, qui Medusa appare in foggia arcaizzante, con sembianze mostruose, zanne di cinghiale, capelli con riccioli a choicciola, viso largo, lingua esposta e serpenti che incoronano tutta la circonferenza della figura. Sono assenti le ali come elemento salvifico e la rappresentazione è quella di un puro archetipo ctonio, connesso alle forze primordiali e al lato emotivo e istintuale della psiche.
IMMAGINE: mosaico con testa di Medusa dall'area archeologica romana di Susa, Tunisia. Le dimensioni del viso sono naturali. Datazione: II secolo d.C. Notiamo in questa figura la tipica dilatazione dello sguardo della Tarda Antichità, in tal caso accentuata dalla necessità di esprimere l'effetto pietrificante degli occhi di Medusa. Gli occhi, con l'iride che ne riempie quasi tutta l'estensione, hanno forma circolare, accentuata dalle ombreggiature dei contorni; lo sguardo non è minaccioso, ma sereno e sognante; il naso dritto; la bocca a cuore; l'ovale pieno e dal colorito roseo; i capelli arruffati da cui fuoriescono 8 serpenti con lingua biforcuta; sulla fronte le ali come simbolo di riscatto ed elevazione di cui abbiamo trattato nel capitolo qui sopra. Sotto il mento si intrecciano due code di serpente come a formare un nastro. Il volto è racchiuso in una cornice a "clipeo" (elemento decorativo che prende il nome dall'ampio scudo rotondo di cuoio usato dai Romani) al centro di una grande sezione quadrata nella quale si diffondono le decorazioni a raggiera policrome che si dipartono dalla figura centrale, rafforzando ancor di più l'effetto magnetico dello sguardo.
I PENDENTI FENICI IN PASTA VITREA
Nella "NATURALIS HISTORIA" di PLINIO IL VECCHIO (23 d.C-79 d.C.) si racconta che alcuni mercanti fenici accesero un fuoco sulla spiaggia con dei blocchi di soda naturale e notarono come questi si fusero con il calore, amalgamandosi con la sabbia circostante: questo causò la formazione delle prime forme di vetro. Tuttavia, recenti scoperte hanno appurato che il vetro fu inventato in MESOPOTAMIA; la più antica formula per la sua produzione si trova in una serie di 4 tavolette della BIBLIOTECA DI ASSURBANIPAL (VII secolo a.C.):
“60 parti di sabbia, 180 parti di polvere di alghe essiccate e 5 parti di gesso”.
All'epoca con questo prezioso materiale venivano creati soltanto ornamenti, come perle di collana e pendenti. Con la tecnica descritta vennero creati dei piccoli pendenti a forma di testa umana, che sembrano dei veri e propri ritratti di persone di varie razze, anche negri e orientali; diverse figurine sono con teste di animali. Le testine sono datate tra il VII e il II secolo a.C. e sono di fattura fenicia, ampiamente diffuse in tutto il bacino del MEDITERRANEO; sono mediamente dai 7 ai 3 centimetri; ne sono state scoperte almeno 700 provenienti principalmente da CARTAGINE, CIPRO e AL MINA. La maggior parte di esse ritrae un tipo iconografico soprannominato BARBABLU', dalla barba ad anelli spiraliformi di colore blu scuro, volto bianco avorio incorniciato da una serie di riccioli tondi blu disposti a semicerchio, grosse sopracciglia blu, naso sottile, labbra strette e chiuse, orecchini e, riguardo al nostro tema, grandissimi occhi circolari rigorosamente blu che occupano la maggior parte del volto, resi con tre anelli concentrici: contorno nero, bianco del bulbo e blu dell'iride; sulla testa del personaggio il foro per appendere. Lo sguardo incantato e incantatore di queste figure potrebbe aver avuto funzione protettiva e, nel contempo, rappresentare o infondere forza spirituale a chi li osservava e a chi li indossava. Il contesto in cui questi monili sono stati scoperti, spesso all'interno di necropoli, lasciano aperti gli interrogativi sul loro significato simbolico. Un importante esemplare di questi amuleti è la collana scoperta nel 1937 a OLBIA, in SARDEGNA, in una delle 47 sepolture a inumazione di epoca punica, composta da 18 elementi, fra cui 5 testine umane dai grandi occhi (4 maschili e una femminile), una testa forse di cavallo e perle colorate, fra le quali due cilindriche con grandi occhi; è datata tra il IV e II secolo a.C. La collana era presente nel corredo funerario di una donna assieme ad uno specchio di bronzo, qualche anfora e una moneta. Questi amuleti, diffusi presso tutte le classi sociali, erano considerati magici e apotropaici, con il potere di respingere con lo sguardo gli spiriti malevoli e, se riposti nelle tombe, di impedire a quest'ultimi di rapire l'anima del defunto. Il soprintendente alle antichità della SARDEGNA che scoprì i manufatti in questa tomba nel 1937, DORO LEVI, affermò che probabilmente questi amuleti venivano realizzati ad ALESSANDRIA D'EGITTO (Museo Archeologico Nazionale di Cagliari).
IMMAGINE: Pendenti fenici policromi in pasta vitrea descritti sopra. Misure: dai 7 ai 3 centimetri. Datazione: VII-II secolo a.C. Fra gli esemplari delle foto si nota il tipico "Barbablù", come descritto nel capitolo sopra. In ultimo la collana di Olbia, Sardegna, scoperta fra le sepolture a inumazione puniche, datata tra il IV e II secolo a.C.; leggi informazioni nel capitolo qui sopra.
LO SGUARDO DIVINO DEGLI IDOLI DI TELL BRAK
TELL BRAK è una collina artificiale ("tell") sulla quale sorgeva un'antica città: NAGAR, oggi sito archeologico, abitata dal VI al II millennio a.C.; si trova in SIRIA, a nord delle antiche NINIVE e ASSUR, lungo un affluente del fiume KHABUR. In quest'area, in epoca storica, regnavano le DINASTIE SUMERE di UR (fine del III millennio a.C.), seguite dall'IMPERO ASSIRO (fino al VII secolo a.C.). Precedentemente, in epoca preistorica nella regione era diffusa la più antica CULTURA NEOLITICA detta "HALAF" (dal VI al V millennio a.C.), basata su pascolo e agricoltura, alla quale è attribuito un Tempio dedicato ad una divinità misteriosa, scoperto nel 1937 ad opera dell'archeologo britannico SIR MAX EDGAR LUCIEN MALLOWAN (1904-1978) e denominato TEMPIO DELL'OCCHIO. Fra le rovine di questo tempio, datato al IV millennio a.C., furono ritrovate più di 300 statuette di alabastro calcificato, datate 6000 anni (un'epoca protostorica). Le statuette misurano dai 13 cm. (le più grandi) ai 3 cm. Sono molte le ipotesi sul significato simbolico di questi manufatti, che ritraggono un soggetto o una coppia di soggetti semplificati fino alla rappresentazione puramente geometrica, piatta e rettangolare, sormontata da due o più occhi affusolati o rotondi, senza volto, in alcuni casi compaiono fino a 6 occhi. Alcune hanno delle figure di animali in bassorilievo sul corpo, in cui si riconosce lo stile dei più antichi siti di CATAL HUYUK e GOBEKLI TEPE. Si ritiene che queste statuette fossero delle offerte votive depositate nel tempio dai devoti, forse come degli ex-voto per rendere grazie, o forse a scopo propiziatorio. Gli occhi degli idoli sono astratti da tutto il resto della figura, come elemento rappresentativo dell'anima, così le persone, e forse interi nuclei familiari, venivano rappresentati mediante i loro occhi. Ma c'è anche un'altra interpretazione, più impersonale: ossia che le statuette siano immagini della stessa divinità a cui era dedicato il tempio, una divinità la cui manifestazione assume diverso significato a seconda del numero di occhi presenti nell'iconografia. Sotto quest'ultimo aspetto questa misteriosa divinità potrebbe essere un prototipo del dio uno e molteplice. Effettivamente, nella successiva iconografia sumera, gli occhi assunsero un'importanza fondamentale, con orbite ingigantite ed esaltazione dello sguardo al cospetto del sacro.
LE STATUETTE GIAPPONESI "DOGU" DEL PERIODO JOMON
La preistoria giapponese comprende un periodo lunghissimo, un arco di tempo da 16.000 anni fa al 400 a.C. Questi sono i millenni in cui si sviluppò sull'isola la cultura JOMON, così genericamente denominata per la particolare caratteristica del vasellame in ceramica decorato con corde impresse sul materiale ancora fresco ("JOMON" significa "segnato da corde"). Ma tuttavia non è da considerare come una cultura lineare, poichè nel corso dei molti millenni ci furono scambi, incontri e fusioni culturali che videro protagonisti molti popoli diversi che si avvicendarono sull'isola. Queste popolazioni vivevano di caccia, pesca e raccolta. Di certo alle lontane radici preistoriche appartengono molti miti dell'antico Giappone, tramandati oralmente e poi trascritti nell'VIII secolo d.C. I primi ritrovamenti archeologici riguardanti la preistoria giapponese risalgono al 1877 e consistono in cumuli di conchiglie detti "KAIZUKA", nelle vicinanze dei quali sono venuti alla luce vasi in ceramica e altri oggetti. Il PERIODO JOMON è caratterizzato dalla pregevole produzione di ceramica fin dai primordi, e si può considerare fra le più antiche del mondo. L'era JOMON si suddivide in 5 fasi:
JOMON INCIPIENTE (14.000-7.500 a.C.), ma questa datazione non è certa, perchè molti studi hanno rilevato la presenza umana sull'isola giapponese già 30.000 anni fa; com'è ovvio, questo fatto, come molte altre scoperte recenti in molte parti del mondo, rimetterebbe in discussione tutte le convenzioni accademiche fino a pochi decenni fa date per scontate. Sappiamo, infatti, che la produzione di ceramiche affonda le radici nel Paleolitico Superiore, pensiamo alle statuette di Dolni Vestonice (Repubblica Ceca, datate 26.000 anni), o ai frammenti di vasellame della grotta di Xianrendong, in Cina, datati 20.000 anni.
JOMON INIZIALE (7.500-4000 a.C.), in cui si testimoniano abitazioni in legno e grandi cumuli "Kaizuka" con resti di crostacei e conchiglie.
PRIMO JOMON (4.000-3.000 a.C.), che vede la produzione delle famose statuette dall'aspetto ibrido animale-antropomorfo denominate "Dogu". In questo periodo iniziano le prime attività agricole.
JOMON MEDIO (3.000-2.000 a.C.), caratterizzato da un perfezionamento nella tecnica del vasellame e dall'edificazione di abitazioni più complesse e confortevoli. Viene, inoltre, introdotta la lavorazione del vetro.
TARDO JOMON (2.000-400 a.C.) in cui si stabiliscono contatti con popolazioni stanziate nell'attuale penisola coreana e la conseguente entrata nell'età del bronzo e del ferro.
L'origine etnica del popolo giapponese è certamente dovuta all'interazione di popolazioni diverse che nel corso dei millenni hanno abitato l'isola. Ma torniamo al tema di questo saggio: l'origine e il significato delle statuette in ceramica DOGU, il cui nome significa "figure di terra" in giapponese, raffiguranti divinità antropomorfe dall'aspetto indefinibile, molte delle quali dai grandi occhi insettiformi, simili a quelli delle statuette in ceramica della civiltà di HARAPPA, nella VALLE DELL'INDO (PAKISTAN), datate più o meno allo stesso periodo. I grandi occhi sono raffigurati chiusi, di forma ovoidale e con una linea trasversale ad indicare le palpebre; questo tipo di soggetti vengono anche denominati "DOGU DAGLI OCCHIALI", ma sembrano piuttosto a teste d'insetto. Queste raffigurazioni JOMON in ceramica, tutte femminili, apparvero circa 12.000 anni fa, la più antica risale a quest'epoca, scoperta nel 2009 presso la prefettura di Shiga nel sito archeologico di AIDANI-KUMARA: si tratta di un torso femminile in ceramica, alto 3,2 centimetri, acefalo, con un foro nella parte superiore. La tecnica e lo stile nella creazione di queste figure ebbero un rapido sviluppo dal MEDIO PERIODO JOMON (3.000-2.000 a.C.) al TARDO PERIODO JOMON (2.000-400 a.C.) con forme e decorazioni sempre più complesse. Le figure DOGU nel tempo hanno subito diverse evoluzioni, secondo le interazioni culturali e le forme spirituali dell'epoca; sono suddivise in molti stili: con testa bidimensionale a forma di cuore e corpo geometrizzato; con testa e occhi di civetta; con occhi a fessura e forme femminili con fianchi larghi; dalla forma teriantropica; dal corpo decorato con motivi spiraliformi, ecc...in una grande e ricca varietà di espressioni, in modo che ogni statuetta ha una sua propria individualità, pur appartenendo ad un contesto cultuale di matrice sciamanica, improntato sulla magia e l'interazione con gli spiriti della natura, e probabilmente i grandi occhi composti richiamano proprio queste forze; il significato preciso rimane comunque un mistero, ma sembrerebbero tutte trasmutazioni della stessa divinità: la DEA MADRE. La loro dimensione si aggira generalmente attorno ai 25 centimetri.
IMMAGINI: statuette in ceramica "Dogu" del Tardo Periodo Jomon, datate circa 1000 a.C. Altezza: intorno ai 25 centimetri. I grandi occhi insettiformi campeggiano enormi su una figura fantastica che probabilmente rappresenta in sè un'ibridazione di tutte le forze della natura e degli esseri ultraterreni.
IMMAGINE: la più antica figurina "Dogu" scoperta in Giappone nel 2009 presso la prefettura di Shiga nel sito archeologico di Aidani-Kumara. Altezza: 3,2 centimetri. Datazione: 12.000 anni (Preistoria). Da notare il naturalismo della figurina in confronto alle statuette protostoriche dalle fattezze irreali.STATUETTE DAI GRANDI OCCHI DELLA CIVILTA' DI HARAPPA E L'OCCHIO DIVINO DEL RE-SACERDOTE
Contesto culturale
La civiltà della VALLE DELL'INDO (estesa fra PAKISTAN, AFGHANISTAN e INDIA), conosciuta come cIVILTA' di HARAPPA, si sviluppò in un arco di tempo da 3.300 al 1.300 a.C. quando si apprese la pratica dell'agricoltura e dell'allevamento. I primi scavi nel sito di HARAPPA sono iniziati nel 1872 ad opera dell'archeologo britannico ALEXANDER CUNNINGHAM; solo nel 1920 gli studi vennero approfonditi con una campagna di scavo diretta dall'archeologo indiano RAI BAHADUR DAYA RAM SAHNI. Si tratta di una civiltà molto avanzata nella pianificazione urbana, con case in mattoni cotti, compresi grandi edifici pubblici, e ingegnosi sistemi di drenaggio e approvvigionamento idrico. Su alcune tavolette di argilla scoperte ad HARAPPA, risalenti al 3.300 a.C., vi è una forma di scrittura con segni a tridente, molto diversa da quella sumera, per cui viene considerata come uno sviluppo indipendente dalla scrittura geroglifica egizia e da quella cuneiforme sumera. A MOHENJO-DARO sono state scoperte le più antiche testimonianze di tessuti in cotone:
"Gli agricoltori della VALLE DELL'INDO furono i primi a filare e tessere il cotone. Nel 1929 gli archeologi recuperarono frammenti di tessuti di cotone a MOHENJO-DARO, nell'attuale PAKISTAN, datati tra il 3250 e il 2750 a.C.. Sono stati datati semi di cotone ritrovati nella vicina MEHRGARH al 5000 a.C. I riferimenti letterari sottolineano ulteriormente l'antica natura dell'industria del cotone del subcontinente. Le scritture vediche, composte tra il 1500 e il 1200 a.C., alludono alla filatura e alla tessitura del cotone" ("Impero del cotone, una storia globale"; 2015, SVEN BECKERT).
I grandi occhi insettiformi delle dee di Harappa e il ritratto in steatite del Re-Sacerdote
I grandi occhi composti d'insetto delle statuette JOMON trovano un'analoga espressione nelle statuette coeve di dee femminili della civiltà di HARAPPA e MOHENJO-DARO, VALLE DELL'INDO (Pakistan), prevalentemente risalenti al II millennio a.C., alte intorno ai 14 centimetri, la più antica delle quali è datata alla I Fase di questa cultura, circa 3.300 a.C., e consiste in un bacino femminile in terracotta, alto 3 centimetri, scoperta nel sito archeologico di HARAPPA. Si sono trovati in tutto, dal 1920, circa 8.500 frammenti di statuette di ceramica; i manufatti erano per la maggior parte danneggiati dal tempo. Sebbene ci sia un filo conduttore culturale tra le varie fasi di questa civiltà, le statuette più antiche si distinguono per la posizione seduta, i seni conici o discoidali, gambe unite, fianchi larghi e volti estremamente semplificati. Nella fase più evoluta compaiono le figure femminili in piedi, assieme ad un certo numero minore di figure maschili. Alcune di esse mostrano volti con becco d'uccello e occhi sempre enormi e sbarrati, altre, a parte l'enormità degli occhi, non mostrano nessun particolare umano del volto e rimangono, nella loro iconografia, indecifrabili; altre ancora lasciano emergere elementi di volto umano: naso, labbra sporgenti e occhi sporgenti discoidali. La caratteristica più affascinante di queste figure è il pesante e alto copricapo a ventaglio con applicazioni di fiori, diademi e altri ornamenti a doppia-voluta. Le figurine maschili si distinguono per la loro silhouette snella, capezzoli esageratamente rilevati e a disco, chignon o copricapo e, a volte, barba. E' celebre il bellissimo ritratto del RE-SACERDOTE di MOHENJO-DARO (Mohenjo-Daro fu, assieme ad Harappa, fra le grandi culture della Valle dell'Indo), in steatite, datato 2000 a.C., alto 17 cm., che ritrae un personaggio dall'espressione serena, raccolta, occhi affusolati di tipo orientale, barba resa a linee parallele verticali, toga con decorazioni a trifoglio; l'elemento più interessante di questa scultura è la presenza, sulla fronte, di un anello circolare che può essere interpretato come un occhio a cerchi concentrici, un'antica tradizione in questa regione, di origine neolitica. Infatti, la produzione di perle con occhi stilizzati circolari divenne molto popolare nella VALLE DELL'INDO, si suppone fossero indossate per allontanare le influenze negative. Ancora oggi, nell'area mediorientale, viene prodotto questo amuleto detto "OCCHIO DIVINO". E' doveroso fare una breve digressione sulle figure antropomorfe maschili per comprendere la complessità di questa cultura, poichè gli esemplari stilizzati sono stranamente coevi di altre figure estremamente naturalistiche, come il TORSO IN DIASPRO ROSSO, alto 7 centimetri, datato 2.500 a.C., scoperto ad HARAPPA ed analizzato da JOHN MARSHALL, archeologo britannico (1876-1958), che rimase sbalordito dall'aspetto della statuetta, che mostra caratteristiche anatomiche perfette, che non hanno nulla da invidiare alle statue della GRECIA CLASSICA, solo che questo perfezionamento della figura umana venne introdotto per la prima volta, negli ultimi 5 millenni, appunto nel periodo classico dell'arte greca, a partire dal V secolo a.C., ovvero duemila anni più tardi delle statuette di HARAPPA. Di figure anatomicamente perfette se ne sono trovate in molto minor numero rispetto a quelle arcaiche, ma ciò non evita di sconvolgere qualsiasi idea di linearità nello sviluppo delle culture e lascia sospettare la presenza di un'elite di artisti illuminati, depositari di ancestrali conoscenze. Dobbiamo comunque precisare che la semplificazione della figura umana nell'arte, così come quella degli animali, ha avuto inizio in EPOCA NEOLITICA o nel TARDO PALEOLITICO, essendo connessa ad una graduale decadenza della spiritualità primordiale, in quanto raffigurazioni umane e animali naturalistiche le troviamo nei contesti delle epoche più remote del PALEOLITICO SUPERIORE: prendiamo ad esempio le veneri di KOSTENKI, Russia, datate 25.000 anni; i frammenti di statuette in pietra calcarea del sito di LISENBERG, Germania, datati 25.000 anni; la VENERE DI LA POIRE, dalla GROTTE DU PAPE, Brassempouy, Francia, datata 27.000 anni; i ritratti umani incisi sulle placchette di scisto della grotta di LA MARCHE, FRANCIA, datati 15.000 anni e molti, molti altri esempi tralasciando le straordinarie immagini faunistiche dell'arte parietale.
IMMAGINE: statuetta femminile in terracotta dal sito archeologico di Harappa, Valle dell'Indo, Pakistan. Datazione: 2500 a.C. circa. Misure: assenti; queste statuette si aggirano, solitamente, intorno ai 14 centimetri. Il petto, i fianchi e le spalle sono resi in modo abbastanza realistico, il volto, al contrario, presenta caratteristiche fantastiche, con enormi occhi d'insetto simili a quelli delle statuette Jomon giapponesi descritte precedentemente, il resto della fisionomia non è identificabile. Indossa una cintura, ornamentazioni nei capelli ricadenti sulle spalle. Come per la precedente, anche questa è modellata con la tecnica dell'applicazione separata degli elementi. (Royal Ontario Museum)
IMMAGINI: statuetta di Re Sacerdote dal sito archeologico di Mohenjo-Daro, Valle dell'Indo, Pakistan. Materiale: steatite. Altezza: 17 centimetri. Datazione: 2000 a.C. Il personaggio ha occhi molto affusolati e semichiusi, espressione serena e imperturbabile, indossa toga con decorazioni a trifoglio. Da notare la presenza dell'anello sulla fronte tenuto dalla fascia che gli cinge il capo: è l'Occhio Divino dell'antica tradizione preistorica, o anche "terzo occhio".
IMMAGINE: disco dorato in steatite e madreperla scoperto fra il 1995 e il 1998 durante gli scavi archeologici nel sito di Harappa, Pakistan. Misure: questi ornamenti si aggirano intorno ai 3 centimetri di larghezza. Datazione: 2000 a.C. Questo disco, scoperto nello stesso luogo della statuetta del Re Sacerdote qui sopra, si connette con lo stesso elemento presente sulla fronte del personaggio e viene considerato precursore del Terzo Occhio della tradizione Indù, che può risalire fino al 7000 a.C.
IMMAGINE: torso maschile in diaspro rosso dal sito archeologico di Harappa, Valle dell'Indo, Pakistan. Datazione: 2500 a.C. Altezza: 7 centimetri. Come detto nel capitolo sopra, lo stile "classicheggiante" di questo manufatto sembra del tutto anacronistico confrontato alle coeve statuette femminili di terracotta della stessa cultura. Di figure realistiche come questa se ne sono trovate altre nel sito di Harappa, anche se in molto minor numero rispetto a quelle chimeriche viste prima. Nel capitolo sopra sono esposte alcune tesi e confronti interessanti con altre epoche.
MESOPOTAMIA: IL RAPIMENTO ESTATICO NELLO SGUARDO DELLE STATUE VOTIVE SUMERE
Contesto storico e culturale
La CIVILTA' SUMERA si sviluppò intorno al 4.000 a.C., in MESOPOTAMIA ("Terra in mezzo ai fiumi"), IRAQ sud-orientale, protraendosi fino al III millennio a.C. Le prime testimonianze di questa civiltà vennero alla luce durante gli scavi in un tempio del SECONDO IMPERO BABILONESE nella zona di UR risalente al V secolo a.C. (MESOPOTAMIA, IRAQ), ad opera dell'archeologo britannico LEONARD WOOLLEY (1880-1960) nel 1922: diversi locali del tempio servivano ad ospitare una scuola per ragazzi e vi furono rinvenuti libri di studio su tavolette d'argilla incise in caratteri cuneiformi; all'interno di queste stanze vennero trovati molti oggetti risalenti ad un'epoca duemila anni più antica della costruzione del tempio babilonese ed erano frammenti di bassorilievi, tavolette scritte e statue; la spiegazione venne da un'iscrizione su un cilindro di ceramica nello stesso locale:
"Qui si vedono iscrizioni su antichi mattoni trovati nel corso degli scavi diretti dal governatore di Ur sul luogo dove sorge il tempio, raccolte fatte per informazione del pubblico".
Si trattava di un vero e proprio museo, dove gli allievi erano tenuti ad osservare le opere dei loro antenati: gli antichi SUMERI. Su quale fosse l'origine di quest'etnia, fondatrice di quella che è considerata la prima civiltà mesopotamica, il dibattito è ancora aperto. Riassumendo, i SUMERI inventarono l'uso della ruota, iniziarono la fusione dei metalli, posero i fondamenti dell'aritmetica, edificarono le prime città. Essi vengono considerati i primi ad inventare la scrittura, ma oggi sappiamo che forme di scrittura più antiche di molti millenni sono testimoniate nel tempio preistorico di GOBEKLI TEPE (risalente a 13.000 anni fa, Turchia) identificate nei libri "La scimmia ambiziosa" e "Una storia di pietra" dell'archeologo FELICE CESARINO; altre testimonianze più antiche di scrittura si trovano fra i resti della cultura neolitica PEILIGANG, in CINA, risalenti a più di 7.000 anni fa; oggi sono riconosciuti da alcuni studiosi come sistemi di scrittura anche le raffigurazioni astratte puntiformi e a barra del PALEOLITICO SUPERIORE, risalenti a decine di migliaia di anni fa. Le città Sumere sorgevano intorno al tempio della divinità a cui erano consacrate; si trattava di città-stato, in perenne lotta fra loro. Nell'epoca più antica, l'autorità dei sacerdoti e delle sacerdotesse che risiedevano nel recinto del tempio derivava direttamente dalla volontà degli dèi e a loro era dovuta la gran parte dei prodotti agricoli, che venivano in seguito redistribuiti nel periodi di carestia: il potere teocratico, infatti, ereditava i principi dell'organizzazione sociale egualitaria protostorica, o comunismo primitivo. La religione politeista comprendeva un numeroso pantheon di divinità come archetipi di forze cosmiche e naturali. Nel corso dei secoli ci fu un'alternanza fra potere religioso e laico: il potere laico aveva come suo esponente il Re e il suo palazzo, il potere religioso i sacerdoti la cui dimora era il tempio. Inizialmente, le due sfere erano unite nella figura del RE-SACERDOTE, affiancato dalla classe aristocratica. In epoca accadica (o di AKKAD), verso il 2.300 a.C., mentre prima veniva eletto dalla classe sacerdotale, il sovrano pretese l'autodivinizzazione, rendendosi così indipendente dal clero e divenendo egli stesso incarnazione del dio patrono della città-stato che governava; capostipite di questo cambiamento fu SARGON di AKKAD, che diede origine ad una nuova dinastia di origine semitica, fondando l'IMPERO ACCADICO. AKKAD era la città che dominava la parte settentrionale della MESOPOTAMIA, alla confluenza dei due fiumi, TIGRI ed EUFRATE; SUMER era il centro di potere della parte meridionale. Intorno al 2.000 a.C. la MESOPOTAMIA cadde sotto il dominio babilonese, decretando la fine della CIVILTA' SUMERA. Le due più importanti città della civiltà Sumera erano URUK e UR. Gli agglomerati urbani erano a pianta circolare e potevano raggiungere fino a 10.000 abitanti; sull'intero complesso urbano dominava il tempo dedicato al dio patrono della città (ogni città-stato era consacrata ad una sua particolare divinità, compresa nel pantheon sacro sumero); questo tempio era chiamato "ZIGGURAT", o "collina del cielo": struttura in mattoni crudi elevata a più livelli, sopra la quale sorgeva la torre del tempio. La più famosa è quella di UR, risalente al 2.000 a.C., dedicata al dio della luna NANNA (o SIN).
Gli occhi incantati delle statuette votive sumere e il busto del Re Sacerdote
Centinaia di statue votive sono state scoperte presso i templi sumeri e nei santuari circostanti; nessun altro periodo storico del Vicino Oriente è mai stato testimoniato da così tanti ritrovamenti. Queste sculture devozionali sono di varie dimensioni, solitamenti realizzate in gesso o pietra calcarea. Le forme anatomiche si presentano rigide e semplificate, anche se si conoscono esempi di figure più realistiche, come il busto di devoto, probabilmente lo stesso RE-SACERDOTE, della città di URUK, datato 3.000 a.C., alto 21 centimetri, coevo agli altri gruppi di statuette depositate nei templi. I lunghi capelli del Re sono raccolti alla nuca da un diadema, la barba dalla linea geometricamente arrotondata è innaturalmente incisa con solchi orizzontali; indossa una spessa cintura ai fianchi che regge il gonnellino, le mani sono chiuse a pugno sull'addome, gli occhi bianchi con pupilla ristretta (miosi) in alabastro sono contornati in scisto nero e nel complesso aggiungono un'impressione di alterità all'intera figura; la pupilla, di cui si nota il punto centrale in ombra, in realtà doveva essere intarsiata ed avere un aspetto più dilatato. Queste figure, come quelle di Harappa trattate precedentemente, dall'aspetto più naturalistico ed anatomicamente accurato rispetto al contesto dell'arte coeva, a mio avviso dovevano costituire reminiscenze di manifestazioni artistiche remote, in seguito sempre più schematizzate. Sono del parere che, come afferma anche la moderna ANTROPOLOGIA STRUTTURALE, non si debba considerare lo sviluppo della conoscenza come qualcosa di lineare e uniforme, come una freccia tesa verso il progresso, quanto piuttosto come una serie di flussi e riflussi nel corso del tempo, con periodi di grande illuminazione spirituale e sviluppo culturale (a cui fa seguito un analogo naturalismo nelle immagini artistiche), subentrati da epoche oscure, durante le quali si verifica nella maggior parte dei casi una sclerotizzazione di principi e valori spirituali, il cui senso profondo è tuttavia caduto nell'oblio.
Gli occhi blu con intarsi di lapislazzuli nelle figure sumere e come elemento simbolico universale
Lo stile delle raffigurazioni nella forma artistica dei primi agglomerati urbani della CIVILTA' SUMERA è fondamentalmente impersonale, con forme anatomiche convenzionali e tratti del volto stereotipati, solitamente in posizioni ed espressioni ieratiche, rapite, con spalle larghe contratte, corporatura robusta, che esprimono una rigidità del corpo e una fissità dello sguardo simile ad una paralisi ipnagogica; tutto ciò allo scopo di tradurre, nell'opera, il rapimento mistico dei devoti al cospetto della divinità. Gli abiti maschili e femminili sono simili; in particolare il "KAUNAKES", una gonna lunga di lana, lavorata in modo da formare lunghe frange su un pannello sottostante di tessuto, era segno distintivo dei dignitari e del sovrano stesso. Il resto della popolazione indossava abiti più semplici, eleganti ma senza fronzoli. Gli occhi blu fissi delle figure sono contornati con scaglie di scisto, così anche le sopracciglia unite ad ali di uccello, mentre le orbite sono intarsi di pietre dure o conchiglie per il bianco, lapislazzuli per il blu dell'iride. Nell'antichità il lapislazzuli era considerato una pietra sacra, legata alla saggezza e alla spiritualità e perciò gli occhi di colore blu non indicavano una caratteristica individuale, bensì avevano un significato puramente simbolico, dimostrando le qualità superiori del devoto nel vortice della contemplazione mistica. Gli occhi blu nelle statue sono una caratteristica quasi universale, utilizzata per evidenziare il carattere sacro della figura o del personaggio ritratto, presente presso gli INCA, in PERU', nell'iconografia del dio VIRACOCHA, o in INDIA in alcune statue del BUDDHA, soprattutto nell'ANTICO EGITTO gli occhi con intersi di lapislazzuli o pietra turchese erano un vero e proprio canone artistico. Scoperta più di 6.000 anni fa, questa gemma dal colore blu oltremare (detto anche "azzurro di Baghdad"), venne trasportata in MESOPOTAMIA lungo la Via della Seta e utilizzata per la creazione di ornamenti, intarsi e per i grandi occhi delle statue votive. Gli EGIZI consideravano il lapislazzuli una pietra curativa dell'anima e della mente, ma anche del corpo per i problemi della vista e del tratto laringeo.
IMMAGINI: dettagli delle 12 statuette del Tempio di Eshnunna (antica città sumera, oggi Tell-Asmar, Iraq). Civiltà Sumera. Le statuette sono state scoperte nel 1934 nel corso di scavi archeologici. Datazione: 2900-2500 a.C. Altezza: dai 72 ai 21 centimetri.
GLI OCCHI BLU COME ELEMENTO SIMBOLICO UNIVERSALE: alcuni esempi:
IMMAGINE: maschera d'oro dalla tomba del SIGNORE DI SIPAN (governante della civiltà Moche). Datazione: III secolo d.C. Misure: 12 x 13 centimetri circa. Gli occhi blu sono intarsi di lapislazzuli. Sipàn è un sito archeologico della civiltà Moche nel Perù settentrionale; la cultura Moche vide gli albori nel II secolo d.C. e tramontò intorno all'anno 1000. La tomba del Signore di Sipàn fu scoperta nel 1987 dall'archeologo peruviano Walter Alva; al suo interno furono rinvenuti 600 oggetti: 451 d'oro, più manufatti d'argento, rame, ceramica, turchese e tessuti. Il personaggio venne sepolto assieme a due guardiani, i cui scheletri si trovano ai suoi lati. Un dettaglio importante è dato dai risultati delle analisi del DNA sullo scheletro del Signore di Sipàn, confermando che il suo gruppo sanguigno era RH negativo, riscontrato solo nel 15% della popolazione mondiale.
IMMAGINE: testa femminile in pietra calcarea, con occhi intarsiati di conchiglia e lapislazzuli, dall'antica città sumera di Tutub, oggi Governatorato di Diyala, Iraq. Datazione: 2600 a.C. Dimensioni: assenti, ma è probabile che si tratti di una delle tante testine di statuette adoranti e in tal caso può essere alta dai 5 ai 7 centimetri. Lo sguardo mostra la consueta esaltazione dei devoti sumeri di fronte alla divinità, un clichè ripetuto nei milleni. Il volto è sorridente, ovale, con sopracciglia unite; la capigliatura ondulata con una treccia arrotolata sul capo.
IMMAGINE: dettaglio della statua lignea del Faraone HOR AWIBRE; XIII Dinastia; regnò dal 1777 al 1775. Dimensioni: 170 cm. La tomba di Hor Hawibre fu scoperta nel 1894 ed è famosa soprattutto per questa statua a misura naturale di legno perfettamente conservata; raffigura il "Ka" (doppio incorporeo) del Faraone; gli occhi sono contornati in bronzo, con l''interno bianco in quarzo e iride in cristallo di rocca.. Il faraone è in piedi; la sua figura è longilinea, ben proporzionata, con spalle larghe, una gamba protesa e postura rigida. Sulla testa il simbolo di due braccia alzate come forza spirituale del sovrano.
IMMAGINE: testa in marmo con occhi blu in lapislazzuli della civiltà dei Sabei, fondatori del Regno di Saba, nell'attuale Yemen, fondato nel 1200 a.C., tramontato nel 275 d.C. Datazione del manufatto: 200 d.C. Dimensioni: informazioni assenti.
IMMAGINE: testina di monaco in avorio, con occhi intarsiati in pasta vitrea. Datazione: IX secolo d.C. Provenienza: monastero benedettino medievale di San Vincenzo al Volturno, Isernia, Molise.I GRANDI OCCHI DELLE STATUETTE VOTIVE DELLA CIVILTA' MICENEA
Contesto culturale e vicende storiche
I MICENEI erano un popolo indoeuropeo che, proveniendo presumibilmente dalle steppe russe, colonizzò la GRECIA continentale nell'ETA' DEL BRONZO (1.900 a.C.). Della stessa stirpe erano DORI, IONI ed EOLI, mentre i MINOICI erano un popolo autoctono dell'isola di CRETA, fondatore della CIVILTA' MINOICA che venne progressivamente assorbita e sostituita dalla cultura micenea. Con il nome generico di "ACHEI" vennero indicati da OMERO tutti i popoli greci, dal PELOPONNESO alla GRECIA continentale. Per molti secoli si credette che fossero un popolo immaginario, nato dalle opere di OMERO, ILIADE e ODISSEA. Ben presto, però, nel 1876, l'archeologo HEINRICH SCHLIEMANN scoprì, su un colle del PELOPONNESO, le rovine della città di MICENE che dal 1400 al 1000 circa a.C. dominò su tutto il MARE EGEO, appurando che le gesta degli eroi omerici e la guerra contro la ricca città di TROIA, dall'altra parte del mare, sulle coste dell'ANATOLIA, erano in una certa misura davvero avvenute. Nel 1871, infatti, vennero alla luce anche le rovine della mitica ILIO (Troia), affacciata su un colle dello Stretto dei DARDANELLI: una posizione strategica per il controllo dei commerci al confine fra EUROPA e ASIA; posizione grazie alla quale si arricchì a tal punto che i suoi tesori furono ambiti dai vicini d'oltremare e forse proprio questa fu la causa principale delle spedizioni di conquista, poi arricchite dal mito, descritte da OMERO, i cui principali protagonisti furono AGAMENNONE (Re degli ACHEI e di MICENE), ACHILLE, ETTORE, ULISSE (o Odisseo), PARIDE, AIACE. Secondo il mito ELENA, moglie di MENELAO, fratello minore di AGAMENNONE (Re degli ACHEI e dell'ARGOLIDE), venne rapita da PARIDE, figlio del Re di TROIA, PRIAMO, e ciò fu la causa scatenante del conflitto. MICENE (1.400-1.000 a.C.) era una città-fortezza, circondata da un'inespugnabile cinta muraria, formata da enormi massi di pietra, tanto che la leggenda narra che fosse opera dei CICLOPI, i giganti dotati di un solo occhio. Sul portale d'ingresso della città (1350 circa a.C.), sopra l'architrave, le sculture di due leoni di profilo costituivano l'emblema della città e probabilmente sorreggevano la statua della DEA-MADRE che vegliava sulla capitale del regno. Nel corso degli scavi archeologici vennero scoperte 6 tombe monumentali a fossa, nelle quali vi erano inumate 19 persone, assieme a corredi di armi, gioielli e maschere funerarie: 5 maschere d'oro di uomini e il frammento di un'altro esemplare, all'interno delle tombe II-IV e V. La più celebre di queste tombe è quella denominata "TESORO DI ATREO", o "TOMBA DI AGAMENNONE" (XIV secolo a.C.): da un lungo passaggio scavato nella collina si accede ad una vasta sala circolare, sormontata da una cupola a cono formata da grandi blocchi di pietra squadrati; all'interno di questa sala erano adagiati, sulla nuda terra, i corpi dei defunti della storpe regale; dopo l'inumazione, il passaggio veniva di murato e ricoperto di terra. Il soffitto della TOMBA DI AGAMENNONE è il più antico tentativo di copertura a volta documentato. Gli scheletri del Re e dei principi avevano il volto coperto da maschere in lamina d'oro con i tratti idealizzati del volto, in tutto 5; vi erano diademi, anelli-sigillo, armi di bronzo, un gran numero di oggetti d'oro pari a 14 chili, compresi i dischetti che adornavano gli abiti. Le armi di bronzo, in particolare, sono di pregevole fattura, con lame ageminate con figure di leoni e scene di caccia. Dopo la sconfitta e distruzione di TROIA, gli ACHEI raggiunsero l'egemonia su tutta l'area, estendendo il loro dominio, oltre alla penisola ellenica, sulle isole circostanti. Verso il 1.000 a.C., quando i DORI, anch'essi indoeuropei e provenienti dall'EUROPA centrale, giunsero sulla penisola greca con le loro armi più potenti di ferro, gli ACHEI vennero a loro volta soppiantati.
L'arte micenea e le statuette votive dagli occhi circolari e globulari
Al ricco corredo funebre sopra descritto, si aggiungono "RYTHON" (boccali) a forma di testa d leone, coppe, statuette votive, sculture di terracotta, ecc... Le STATUETTE VOTIVE, in ceramica smaltata (o invetriata) si suddividono in molte tipologie: animali, figure di uomo-uccello, o "dea-uccello" con ali al posto delle braccia, estremamente stilizzate e senza attributi fisici, con testa a becco di uccello, simili a quelle neolitiche di molte migliaia di anni più antiche, come quelle scoperte, ad esempio, nel villaggio neolitico di SAMMARDENCHIA (UDINE), risalenti a circa 7.000 anni fa. Altre ritraggono personaggi maschili nudi dalle forme molto schematizzate e con influenze minoiche. Figurine femminili dal vestito a campana e dalle forme anatomiche geometrizzate. Due tipologie di figurine femminili, alte in media 20 centimetri, per la loro forma simile a lettere greche vengono denominate del tipo "THAU", "PSI" e "PHI": le "PSI" sono figure schematiche ad ali aperte e rappresentano la DEA-UCCELLO; le "PHI" sono figure schematiche con corpo discoidale; le "THAU" hanno braccia tronche aperte a forma di croce e sono sempre schematiche. Quelle dalla testa antropomorfa hanno solitamente grandi occhi circolari, dipinti o resi come globi in rilievo. Alcune di esse, femminili, dal lungo collo, mostrano volti sorridenti e una particolare enfasi nella raffigurazione degli occhi, perfettamente circolari e sormontati da sopracciglia disegnate come a formare dei raggi; questo può rendere l'idea di un'espressione di estatica sorpresa. Queste figurine di ceramica, prodotte artigianalmente in massa, sono state scoperte in contesti cultuali, sia della GRECIA continentale che delle isole. La loro funzione è quella di ex-voto e consistono in rappresentazioni in scala ridotta di divinità ancestrali. Si può dire che la forma artistica minoica fu matrice del successivo stile miceneo e le due espressioni sono, nei loro tratti fondamentali, convergenti, nonostante la CIVILTA' MINOICA, autoctona, fosse pacifica, colta, basata sull'agricoltura, la pesca e l'allevamento, mentre i MICENEI erano una società di guerrieri, aggressivi e bellicosi. Ma la statuaria micenea comprende anche una produzione di più alto livello, come statuette naturalistiche in terracotta di personaggi intenti a qualche occupazione, metope arcitettoniche, sculture in avorio come il GRUPPO CON DUE DIVINITA' FEMMINILI GEMELLE e un fanciullo, da MICENE (XIII secolo a.C.) al Museo Archeologico Nazionale di Atene; i personaggi di questo gruppo scultoreo, alto appena 7,5 centimetri, indossano abiti tipicamente micenei; le fattezze, la vita stretta e la sinuosità delle figure ricordano le statue indiane. Una delle due divinità è priva di testa, l'altra ha il tradizionale sguardo fisso e ipnotico del dio o del fedele rapito dalla sua visione. Le raffigurazioni gemellari o doppie come rappresentazioni della dualità universale risalgono al PALEOLITICO SUPERIORE; un esempio è la statuetta d'avorio del sito all'aperto di KHOTYLEVO, RUSSIA, datata 22.000 anni, alta 8 cm., fino alle rappresentazioni neolitiche di CATHAL HUYUK, TURCHIA, risalenti a 9.000 anni fa, alte 17 cm., o alla scultura delle dee gemelle dai templi megalitici di MALTA, risalente a 5.000 anni fa, alta circa 15 centimetri.
GLI SGUARDI INCANTATI DEI RITRATTI DEL FAYYUM
L'oasi del FAYYUM si trova in EGITTO, a sud del Cairo, in mezzo al deserto ed è una delle zone più fertili della regione, grazie ad una depressione che permise il drenaggio dell'acqua del NILO per mezzo di un canale. L'oasi del FAYYUM venne bonificata durante il regno di AMENEMHAT III (1844-1797 a.C.). Durante il PERIODO TOLEMAICO, posteriore alla morte di ALESSANDRO MAGNO nel 323 a.C., e con la successiva conquista dell'EGITTO da parte dei ROMANI nel 30 a.C., l'oasi del FAYYUM divenne un insediamento di coloni, la maggior parte soldati greci e romani, a cui vennero concessi dei lotti di terreno come ricompensa per i loro servigi. La coltivazione di questi campi veniva solitamente affidata a contadini egiziani che giungevano da tutta la regione; in questo modo, si venne a creare un complesso amalgama di etnie. Nella località di HAWARA (Medinet-al-Fayyum) è venuta alla luce una piramide di AMENEMHAT III, con il sarcofago del faraone, due casse con vasi canopi e la tomba della figlia, la principessa NEFERU-PTAH, il cui corpo era circondato da un ricco tesoro; nello stesso luogo venne scoperta, dall'archeologo FLINDERS PETRIE (1853-1842) nel 1888, una grande NECROPOLI del periodo tolemaico-romano assieme a centinaia di mummie intatte con il volto ricoperto da tavolette lignee con il ritratto dei defunti. Ma i primi ritratti del FAYYUM giunsero in EUROPA nel 1615, assieme a due mummie acquistate dall'esploratore italiano PIETRO DELLA VALLE che ne fece una relazione nei suoi appunti di viaggio. La loro DATAZIONE copre un lasso temporale dalla fine del I secolo a.C. al III secolo d.C. Grazie al clima secco del deserto i dipinti si sono conservati in ottime condizioni: si tratta di circa 600 ritratti realizzati con tempera e cera d'api mescolate e fuse, una tecnica denominata "encausto". I dipinti svelano la tradizione religiosa di questi coloni connessa ai culti dell'ANTICO EGITTO, assimilati dalle dinastie tolemaiche prima, dai romani in seguito. Com'è ovvio, questa millenaria tradizione era associata alla pratica della mummificazione dei defunti come necessario atto rituale. Riguardo alla tecnica pittorica, in alcuni esemplari la tempera è stata lasciata opaca. I supporti lignei sono soprattutto di quercia, cipresso e cedro; molti altri sono dipinti su tela di lino, la stessa con cui sono avvolte le mummie nei sudari; misurano mediamente 37 x 23 cm., con volti a grandezza naturale. I pigmenti sono stati ricavati da minerali come l'"azzurro egiziano" (il più antico pigmento sintetico, ottenuto da rame e calcio), il "minio" (ossido di piombo per il rosso), lo stannato di piombo per il giallo, carbonato o solfato di calcio per il bianco, carbone per il nero, malachite per il verde, un colorante di argilla per la pelle in tutte le sue tonalità, oltre a decorazioni in foglia d'oro, come corone d'alloro e sfondi. I colori sempre vividi ed inalterati sono dovuti all'alta qualità della tempera, una delle tecniche più antiche del mondo, ottenuta da un impasto cromatico mescolato a sostanze collanti, fra le più comuni l'uovo e la cera. La pittura a TEMPERA è una tecnica che accomuna tutte le più antiche civiltà: gli antichi EGIZI, CINA, CIVILTA' MAYA, GIAPPONE, INDIA, ecc...Già nella PREISTORIA questa tecnica veniva utilizzata, mescolando argille di vario genere con sostanze collanti vegetali. Ma torniamo all'espressione artistica dei RITRATTI DEL FAYYUM (o Fayum), dipinti con mano sicura a sottili pennellate che creano sapienti effetti di luce e ombre; ce ne sono di diverse tipologie: da quelle arcaizzanti, dalle caratteristiche più immediate e spontanee, a quelle sufficientemente realistiche, fino a quelle estremamente realistiche, al punto che la luminosità dello sguardo, la trasparenza del corpo vitreo suggerita dal riflesso di luce, i segni distintivi di ogni persona nei lineamenti del viso dimostrano l'assenza di ogni riferimento a modelli di base. Lo sguardo è sempre rivolto verso lo spettatore e l'artista vi ha indirizzato tutta l'intensità e la forza espressiva; non sono sguardi fissi e attoniti come quelli delle immagini arcaiche, ma estremamente vivi, vibranti, presenti e, al contempo, sognanti. Questi ritratti ci permettono di comunicare con l'interiorità dei soggetti annientando letteralmente i duemila anni trascorsi fra noi e loro; i chiaroscuri, la morbidezza e la luminosità dell'incarnato rendono l'immagine estremamente realistica. Il bianco del bulbo oculare è sempre un po' adombrato (non candido come nell'iconografia arcaica che irrigidisce lo sguardo), ponendo l'accento sulle sfumature dell'iride se gli occhi sono chiari, e sulla trasparenza dell'umor vitreo indicata dal piccolo punto bianco del riflesso della luce. I soggetti hanno generalmente occhi scuri, marroni, pochi mostrano tonalità più chiare color nocciola con la pupilla ristretta per porre in risalto il colore e l'espressione. Le acconciature femminili sono a volte molto elaborate, con lunghe trecce avvolte sulla cima del capo o chignon, come il ritratto (fra i meglio conservati) di ISIDORA ("dono di Iside"), su legno di tiglio, di 48 x 36 cm., datato al 100 d.C. circa; altre volte non vi è nessuna acconciatura e le donne appaiono così com'erano nella vita di tutti i giorni, scapigliate o un po' trasandate secondo il carattere di ognuna, come il ritratto di donna anziana su tavola al Museo di Zurigo datato 210 d.C. circa, di 31 x 17 cm. L'abbigliamento femminile è più vario, accompagnato da gioielli e orecchini d'oro o di pietre preziose. La corona d'alloro dipinta in foglia d'oro sul capo dei soggetti simboleggia la corona solare del dio RA; si tratta della CORONA DI GIUSTIFICAZIONE poichè il defunto che in vita ha trionfato sui propri nemici interiori ha sconfitto il potere della morte. Nella GRECIA CLASSICA l'alloro era l'albero consacrato ad APOLLO e alla vittoria. Dobbiamo però notare che poche delle persone ritratte portano la corona d'alloro e chiederci, dunque, se i soggetti arricchiti da questo particolare avessero delle doti non comuni, o abbiano compiuto buone opere per la comunità.
<< L'incoronazione del poeta, dell'artista o del vincitore, con alloro non rappresenta la consacrazione esteriore e visibile di un'attività, ma il riconoscimento che quest'attività, per il semplice fatto che esiste, presuppone già una serie di vittorie interiori sulle forze negative e dissolventi dello stadio inferiore. Non c'è opera alcuna senza lotta nè trionfo, per questo l'alloro esprime l'identificazione progressiva del lottatore con i motivi e le finalità della sua vittoria, associando anche il significato generico di fecondità che appartiene a tutta la vegetazione >>. ("Il libro dei simboli", JEAN-EDOUARDO CIRLOT, pag.70)
Nei soggetti maschili è molto presente il tipo dalla carnagione scura con capigliatura crespa o ad anelli ricadenti a caschetto; altri tipi più "caucasici" hanno capelli lisci ricadenti a caschetto o semplicemente corti, di colore castano; la barba è frequente ma non troppo. I soggetti anziani sono calvi o brizzolati, indossano generalmente la toga virile bianca. Gli uomini variano dal tipo "filosofo" o uomo colto (come quello a tempera su gesso al Museo Egizio del Cairo, datato al II secolo d.C., con lineamenti nobili, viso ovale, barba curata, capelli brizzolati e grandi occhi dallo sguardo profondo), a quelli più semplici e disinvolti dallo sguardo ingenuo, fino a quelli più rudi dallo sguardo aspro, come un ritratto maschile al Museo Puskin d Mosca. Per quel che riguarda i ritratti dallo stile arcaicizzante alcuni hanno volti aggraziati, sebbene dai tratti ingenui, altri mostrano caratteristiche piuttosto grottesche, con tratti del volto e del collo geometrizzati: un'eco del prossimo stile pittorico paleocristiano. Fra i diversi ritratti di bambini ne spicca uno con la tipica tonsura infantile dell'ANTICO EGITTO: testa completamente rasata con treccia su un lato e due ciuffetti di capelli sulla fronte; gli occhi sono grandissimi, scuri, la pelle è chiara e il collo lungo; il bambino accenna un timido sorriso (150 d.C., collezione J.Paul Getty, Malibù). Della grande arte pittorica dell'ANTICA GRECIA, cioè le opere su tavola e ad affresco, è andato purtroppo tutto perduto, sia a causa dei materiali deteriorabili che della distruzione avvenuta con la conquista romana; ciò che rimane sono per lo più pitture vascolari impersonali a figure nere e figure rosse. Delle opere dei grandi pittori greci come PARRASIO, APELLE, ZEUSI...non rimangono altro che le descrizioni ammirate dei testi antichi e possiamo solo immaginarne la grandiosità. Tuttavia, un barlume dell'espressione artistica della pittura pre-romana è stato sicuramente ereditato dai ritrattisti del FAYYUM, eredi di una lunga tradizione precedente. I dipinti del FAYYUM ritraggono per la maggior parte persone giovani o di mezza età, oltre a diversi bambini e qualche anziano; tuttavia, l'intensità espressiva del volto e dello sguardo lascia supporre che queste effigi siano state realizzate quando le persone erano in vita e fossero tenute in casa, come tradizionalmente veniva fatto dalle famiglie facoltose o nobili nei secoli successivi, e che solo dopo la morte fossero posti sopra il volto della mummia e fissati con le sue stesse fasce di lino. Infatti, l'artista avrebbe dovuto avere un'eccezionale memoria della persona viva per realizzare un'immagine così espressiva e ciò può essere possibile, ma mi sembra più plausibile l'ipotesi di un "ritratto posato". Questo discorso però può cambiare nel caso dei ritratti sulle mummie infantili, che raffigurano il bambino o la bambina immortalati nella stessa età del decesso. Nella tradizione esoterica dell'ANTICO EGITTO, il KA (o forza vitale impersonale) e il BA (l'individualità), esigevano la creazione di un'immagine del defunto in modo che egli vi si potesse riconoscere, acquisendo memoria di sè perchè non cadessero nell'oblio le qualità acquisite durante la sua vita terrena. E, a questo proposito, il potere magnetico dello sguardo nei ritratti di EL FAYYUM doveva svolgere egregiamente questo compito. A tutta l'attuale collezione, sparsa in tutti i più importanti musei del mondo, dei RITRATTI DEL FAYYUM si devono aggiungere quelli, non ancora definitivamente documentati, relativi alla scoperta di una nuova necropoli nel 2022, consistente in un enorme edificio funerario di epoca tolemaica e romana, sempre nell'oasi di EL FAYYUM, nella zona di GERZA.
IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)
IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)
IMMAGINE: Ritratto di giovane uomo. Tempera a encausto e oro su tavola, dalla necropoli nel Fayyum, Egitto. Datazione: 130-50 a. C. Dimensioni naturali.(Museo Pushkin delle Belle Arti, Mosca)L'ACCENTO SULLO SGUARDO NELL'ARTE CRISTIANA COPTA
Contesto storico e teologico
Verso il IV secolo d.C. l'IMPERO ROMANO contava già un gran numero di convertiti alla nuova RELIGIONE CRISTIANA; cristiani erano molti militari dell'esercito, ministri dello Stato e anche appartenenti alla famiglia imperiale. Nel 311 d.C., l'Imperatore PRIMUS AUGUSTUS GALERIO promulgò l'EDITTO DI SERDICA (Sofia, Bulgaria) con il quale legittimò in parte la religione cristiana, fino ad allora bandita, concedendo la libertà di riunione. Due anni più tardi, l'Imperatore COSTANTINO promulgò l'EDITTO DI MILANO con cui venne riconosciuta la piena libertà di culto; nel tempo, vennero concessi altri privilegi alla chiesa cristiana, come l'immunità sacerdotale, la possibilità di ricevere donazioni ed ereditare patrimoni, oltre al riconoscimento della domenica come gioro festivo. Sotto l'Impero di COSTANTINO, tuttavia, religione cristiana e culti pagani erano ugualmente ammessi. COSTANTINO, però, accettò pienamente la religione cristiana soltanto sul letto di morte, nel 337 d.C., facendosi battezzare dal vescovo EUSEBIO di NICOMEDIA. Infine, nel 380 d.C., l'IMPERATORE TEODOSIO I dichiarò la RELIGIONE CRISTIANA come culto ufficiale dell'Impero. Alla morte di TEODOSIO l'Impero venne diviso fra i suoi figli ARCADIO e ONORIO: al primo spettò l'Impero d'Oriente, al secondo l'Impero d'Occidente. Nei primi secoli del Cristianesimo, si verificarono numerose eresie combattute dalla CHIESA CATTOLICA di ROMA, come quella di EUTICHE, patriarca di COSTANTINOPOLI nel V secolo d.C., il quale sosteneva l'essenza unicamente divina di CRISTO, rinnegandone in questo modo la doppia natura, umana e divina, come vero Dio e vero Uomo. Nel 451 d.C., con il CONCILIO ECUMENICO DI CALCEDONIA convocato dall'Imperatore MARCIANO e da sua moglie PULCHERIA, in accordo con il PAPA d'allora LEONE MAGNO, venne condannata l'eresia del patriarca dissidente. Eppure, la nuova concezione di EUTICHE non potè essere sradicata completamente, anzi, trovò un suo grande sostenitore proprio nel patriarca di ALESSANDRIA: DIOSCORO, che la diffuse in tutto l'EGITTO creando uno scisma con la CHIESA di ROMA. Nacque così la CHIESA COPTA ORTODOSSA, con a capo il patriarca di ALESSANDRIA che oggi risiede al CAIRO; i rituali e le cerimonie di questa Chiesa differiscono in molti aspetti da quelle cattoliche. Nel 641, all'arrivo degli ARABI, quasi tutti gli EGIZIANI erano cristiani, ma durante il lungo periodo di dominazione araba, quasi tutti vennero convertiti all'ISLAM; tuttavia, una parte della popolazione non accettò l'imposizione della nuova religione, rimanendo di fede copta. La più antica chiesa copta è la CHIESA SOSPESA, in un vecchio quartiere copto del CAIRO, risalente al III secolo d.C. Gli antichi edifici religiosi copti hanno una struttura simile a quella delle basiliche romane: pianta rettangolare, porticato con portale d'ingresso, interno diviso in tre navate delimitate da colonnati. Sulle pareti di questi edifici si possono ammirare le più significative espressioni dell'ARTE COPTA, con scene che narrano i più importanti episodi della vita di GESU', assieme ad entità angeliche e rappresentazioni di esperienze mistiche.
L'arte copta e il riflesso dello stile del Fayyum
L'ARTE COPTA si sviluppò nei primi secoli dell'era cristiana in EGITTO, protraendosi fino alla conquista ottomana nel XVI secolo. Lo stile copto è affine a quello coevo bizantino, dalle immagini convenzionali semi-naturalistiche ed espressive, a quelle geometrizzate, fisse e semplificate al punto da divenire puramente simboliche. Nei primi secoli le immagini sacre cristiane vennero spesso affiancate da figure della mitologia greca classica, come Dioniso, Afrodite, Orfeo, Baccanti, ecc..., o anche da reminiscenze dell'ANTICO EGITTO come la croce Ankh. Nelle raffigurazioni pittoriche e nelle sculture copte sopravvisse la tradizione dello stile artistico dei RITRATTI DEL FAYYUM, con l'accentuazione dello sguardo nei grandi occhi dilatati dei personaggi, che però hanno perso i tratti realistici della tradizione pittorica greco-romana: vi è uno sguardo generalmente fisso e attonito, con occhi cerchiati ad accentuarne la grandezza e sopracciglia a semicerchio. Nel complesso, i volti e le figure intere appaiono semplificate e geometrizzate, a volte senza riguardo alle proporzioni del corpo. Talvolta gli occhi appaiono uniti, i visi circolari e gli elementi del volto schematizzati. Gli occhi affusolati e uniti sono un canone artistico ricorrente dell'ARTE COPTA, come ad esempio nel frammento di FRONTONE IN PIETRA con due putti che reggono una corona d'alloro che incornicia una croce greca, esposto al Museo del Cairo e datato al IV secolo d.C. circa. Gli occhi uniti e i tratti del volto che sembrano annullare i volumi fra gli elementi di destra e sinistra (naso, bocca) producono un sentimento di unione, di superamento del dualismo ed hanno, forse, lo stesso valore simbolico delle mani giunte in preghiera. Altri esempi iconografici si presentano meno distaccati dalla realtà, con la naturale separazione degli occhi, anche se appaiono sempre molto vicini, come nell'affascinante VOLTO DI CRISTO fra due angeli in un affresco del MONASTERO DI SANT'APOLLO, BAWIT, EGITTO, datato VI secolo circa d.C. e conservato al Museo Coptico del Cairo; questo volto ha grandissimi occhi chiari dal colore indefinibile che osservano un punto lontano, naso dritto e sottile, bocca a cuore, sopracciglia arcuate e capelli e barba neri su una carnagione bianchissima che accentuano l'espressività nel suo complesso; gli angeli sono figurine semplici e sorridenti ai suoi lati nell'atto di sostenere la grande aureola di fuoco solare; sopra il capo la scritta "Sotir" (Salvatore). Il MONASTERO DI SAN MACARIO IL GRANDE (da non confondere con l'omonimo e coevo Macario d'Alessandria), fondato dallo stesso santo nel IV secolo d.C., nel governatorato di BEHEIRA, in EGITTO, e il MONASTERO DI SAN PACOMIO, a PEBU, EGITTO, sono ad oggi i più antichi edifici religiosi copti esistenti.
IMMAGINE: volto di Cristo fra due angeli in un affresco del Monastero di Sant'Apollo, Bawit, Egitto, datato VI secolo circa d.C. e conservato al Museo Coptico del Cairo.IMMAGINE: frontone di pietra con due putti che reggono una corona d'alloro con al centro una croce greca. Esposto al Museo del Cairo e datato al IV secolo d.C.
L'arte copta, l'affresco di San Macario e il Serafino dai molti occhi
Il MONASTERO DI SANTA MARIA EL-SOURYAN, governatorato di BEHEIRA, EGITTO, contiene uno degli affreschi più interessanti sotto il punto di vista simbolico dell'ARTE COPTA: durante un restauro, nel 2014, sulla parete sud della navata della chiesa è venuto alla luce un complesso di affreschi siro-copti datati all'888 d.C., che si aggiungono all'immagine dei tre patriarchi in paradiso (ABRAMO, ISACCO, GIACOBBE) già scoperta nel 2000; vi sono due santi a cavallo, posizionati frontalmente, non identificati, MERCURIO accanto ad una santa, pannelli con iscrizioni e, soprattutto, lo spettacolare affresco di SAN MACARIO afferrato da un SERAFINO con sei ali verdi completamente ricoperte di occhi: due ali ripiegate come un manto sulla figura, formanti in basso un motivo geometrico in cui sono racchiusi i pedi, due sulle spalle e due unite sopra il capo. Dalle sue spalle fuoriescono due teste: di toro e di leone. Sopra la figura dell'angelo l'aquila. La visione di quattro esseri viventi anche in forma di animali (un leone, un vitello, un uomo e un'aquila) che attorniano il trono di Dio è descritta nel LIBRO DELL'APOCALISSE di GIOVANNI: hanno tutti sei ali e sono pieni d'occhi davanti e dietro; questi esseri rappresentano forze angeliche. L'angelo dell'affresco afferra con decisione il braccio di SAN MACARIO per condurlo nel deserto di WHADI AL-NATRON. I due pannelli con iscrizioni in siriaco e copto scoperti sulla stessa parete narrano della morte di SAN MACARIO nel 390 d.C. Nella "VITA DI SAN MACARIO L'EGIZIANO", un testo agiografico scritto dopo la morte del santo, in lingua copta-siriaca, si narra che il SERAFINO apparve a SAN MACARIO mentre stava celebrando una messa, guidandolo poi verso il deserto per mostrargli il luogo dove avrebbe dovuto sorgere il monastero. In una versione della storia l'angelo viene descritto con sei ali e molti occhi. MACARIO porta una tunica marrone lunga fino ai piedi, sopra la quale è posto un mantello bianco chiuso sul davanti con una specie di colletto a linee sottili; ha capelli e barba grigi, volto allungato, sguardo calmo e con una mano aperta compie un gesto di accettazione. Sul lato destro, in dimensioni più piccole, appare SAN MACARIO ALESSANDRINO, suo contemporaneo, in relazione ad un racconto su un grappolo d'uva apparso miracolosamente fuori stagione. I SERAFINI vengono descritti nei testi sacri con sei ali: il numero di ali è relativo alla potenza spirituale dell'entità. L'etimologia di "serafino", dall'ebraico "serafin", deriva dal verbo "saraf", "ardere", e indica la gerarchia angelica più vicina a Dio, quindi ruotante attorno al suo centro. I molti occhi sulle ali dell'angelo rappresentano il potere onniveggente che penetra ogni cosa e a cui nulla può sfuggire; anche in questo caso assistiamo alla doppia valenza di un archetipo: molti occhi possono essere simbolo di dispersione orizzontale nella molteplicità, come anche di percezione che può giungere ovunque senza ostacoli fisici o spazio-temporali. Le sei ali rappresentano per ogni coppia una specifica funzione spirituale: due per volare, due per coprire i piedi e due per coprire il volto al cospetto di Dio, poichè la sua visione non pò essere sostenuta nemmeno dalle entità a lui più vicine. La gerarchia angelica immediatamente inferiore ai SERAFINI è quella dei CHERUBINI descritti come aventi quattro ali. Leggiamo la descrizione delle entità angeliche in EZECHIELE 1:5-11:
"Nel centro appariva la forma di quattro esseri viventi; e questo era l'aspetto loro: avevano aspetto umano. Ognuno di essi aveva quattro facce e quattro ali. I loro piedi erano diritti, e la pianta dei loro piedi era come la pianta del piede di un vitello; e brillavano come il bagliore del bronzo lucente".
Nella sede del SETTIMO CIELO, più in basso dei CHERUBINI, troviamo gli esseri angelici detti TRONI, descritti come delle ruote costellate da molti occhi. Le entità intermediarie fra la dimensione superiore e gli uomini, assieme alla loro interpretazione visiva, sono concetti che affondano le radici in conoscenze esoteriche ancestrali e precedenti le antiche civiltà a noi note. Per esempio, il LAMASSU (detto anche SEDU) della tradizione MESOPOTAMICA è uno spirito protettore che nella tradizione cristiana viene denominato ANGELO CUSTODE; l'aspetto del LAMASSU è quello di un toro alato con testa umana. Gli DEI SUMERI vengono raffigurati generalmente con quattro ali, due rivolte verso l'alto e due verso il basso, che identificano la loro natura intermedia fra il mondo superiore divino e la sfera umana. Anche demoni terrificanti come PAZUZU, dio dei venti portatori di carestie, venne raffigurato con quattro ali, un braccio indicante verso l'alto e uno verso il basso come nella famosa statuetta sumera presente nel film "L'Esorcista"; gestualità simbolica ripresa nell'immagine esoterica del BAPHOMET medievale. Nella MITOLOGIA GRECA il nome ANGHELOS significa "Messaggero": termine con cui veniva indicato il dio HERMES come messaggero degli dèi.
IMMAGINI: affresco copto di San Macario (descritto nel capitolo sopra). Datazione: 888 d.C.Monastero di Santa Maria El Souryan, Governatorato di Beheira, Egitto. Venuto alla luce durante un restauro nel 2014.Raffigura San Macario, fondatore dell'abbazia, accompagnato nel deserto da un Serafino con sei ali costellate di occhi.
Leggiamo ancora un brano illuminante dell'esoterista spagnolo JEAN-EDOUARDO CIRLOT (1916-1973) sul simbolismo degli occhi nell'iconografia, sui significati occulti e sulle molteplici forme che possono assumere:
<< L'espressione di PLOTINO: "l'occhio non potrebbe vedere il sole se non fosse in un certo senso esso stesso un sole", esprime la base e l'essenza del problema. Essendo il sole fuoco della luce e questa, a sua volta, simbolo dell'intelligenza e dello spirito, l'atto di vedere esprime una corrispondenza con l'azione spirituale e simboleggia, di conseguenza, il comprendere. Per questo, l'OCCHIO DIVINO, come lo chiamavano gli EGIZI, quale segno determinativo (OUADZA), simboleggia ciò che alimenta il fuoco sacro o l'intelligenza nell'uomo, cioè OSIRIS. E' molto curiosa la concezione analitica egizia dell'occhio o, meglio, del cerchio dell'iride al cui centro sta la pupilla, come "sole nella bocca" (verbo creatore). Il pittore surrealista belga RENE' mAGRITTE ha dipinto quest'analogia del sole e dell'occhio in uno dei suoi quadri più ambigui. Il possedere due occhi esprime la normalità fisica e il suo equivalente spirituale; per questo, il TERZO OCCHIO è simbolo di sovrumanità e di divinità. Nel caso di un OCCHIO UNICO, il significato è ambivalente; per il fatto di essere meno di due (normalità) esprime infraumanità, tuttavia la sua posizione nella fronte, al di sopra del luogo stabilito dalla natura, sembra alludere a poteri extraumani che, realmente (mitologicamente), concorrono alla natura del CICLOPE. D'altra parte, l'OCCHIO FRONTALE va associato all'idea di distruzione, per ragioni ovvie se è unico, ma anche quando appare come TERZO OCCHIO, come nel caso di SHIVA. Questo riguarda una delle sfaccettature del simbolismo del tre che si può esprimere come passivo, attivo, neutro e riguarda anche: la creazione, la conservazione, la distruzione. Gli OCCHI ETEROTROPI, cioè spostati dal loro luogo anatomico e situati in diverse parti del corpo nelle raffigurazioni fantastiche, angeliche o concernenti divinità: mani, ali, busto, braccia, luoghi diversi dalla testa, ecc..., alludono alla trasposizione spirituale della visione, cioè alla CHIAROVEGGENZA. Posti sulla mano, per esempio, si associano al simbolismo di questa ed esprimono, di conseguenza, l'azione chiaroveggente. L'estrema MOLTEPLICITA' DI OCCHI contiene due aspetti che non bisogna dimenticare. Si riferisce alla notte, con le sue miriadi di stelle e ottenebra, paradossalmente, il possessore di questi occhi. Inoltre, a conferma di questo fatto, dobbiamo ricordare che nella dottrina simbolista, la molteplicità è sempre segno di interiorità. Queste ambivalenze sono molto frequenti nel mondo dell'inconscio e delle sue emanazioni immaginistiche. La vicenda del pastore ARGO, che con i suoi numerosi occhi non può evitare la morte, è molto eloquente in proposito. L'AVVERSARIO, SATANA in ebraico, è stato rappresentato in modi molto diversi, alcuni dei quali inerenti al tema che stiamo trattando. Un TAROCCO, conservato al Museo di Stampe di Parigi, lo raffigura come un ARGO, con molti occhi diffusi per tutto il corpo. Questa raffigurazioe simbolica coincide con un'altra frequente nelle rappresentazioni di demoni, che consiste nel trasformare in volti le parti del corpo che possiedono una certa autonomia di funzione o che corrispondono a funzioni ben precise. La molteplicità di visi e di occhi si riferisce alla scomposizione, alla dissoluzione psichica che contiene, alla radice, l'idea di demoniaco (smembramento) contrapposto alla volontà mistica di integrazione nell'Uno >>. ("Il libro dei simboli", JEAN-EDOUARDO CIRLOT, pag.313-314, voce "Occhio")
DIVINITA' CON UN OCCHIO SOLO - ESEMPI E SIMBOLISMO
IL BRONZETTO DELLA DIVINITA' NURAGICA DAI 4 OCCHI
IMMAGINE: bronzetto che raffigura una divinità con 4 occhi e 4 braccia. Civiltà Nuragica. Provenienza: Albini, Teti, Nuoro, Sardegna. Datazione: VIII-VII secolo a.C. Altezza: intorno ai 20 centimetri. E' incerto se sia la rappresentazione di una divinità o di un eroe la cui moltiplicazione degli attributi indica amplificazione delle facoltà e forza straordinaria. Simbolicamente, il numero 4 è legato al Tetramorfo come principio di quaternità e conservazione dell'ordine cosmico (connesso ai quattro punti cardinali) contro le forze del caos; questo principio era conosciuto nell'antica cultura megalitica e probabilmente affonda le radici in epoca primordiale.LE RAFFIGURAZIONI DEL BUDDHA E GLI OCCHI CHIUSI DELLA SAGGEZZA INTERIORE
Cenni su origini e filosofia buddista
Molti secoli prima dell'avvento del CRISTIANESIMO in Occidente, in INDIA si erano sviluppate forme di pensiero elevatissime, a partire dagli antichi INNI VEDICI, ai testi BRAHMANA e UPANISAD, dei quali il BUDDISMO fu un'evoluzione. SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA nacque l'8 aprile 566 a.C. a Kapilavastu, nella regione dell'odierno Nepal, e morì a 80 anni, nel 480 a.C., a Kusinagar. Fu asceta e filosofo e apparve come colui che aveva trovato l'illuminazione e la Verità. Dopo lunghi anni di meditazione e rinunce, il BUDDHA iniziò a diffondere la sua conoscenza fra le genti; il suo nome stesso significa: "Illuminato", "Sublime". Egli aveva superato ogni attaccamento terreno, ogni illusione e ogni forma di egoismo, invitando ognuno a seguire il suo esempio per il raggiungimento del NIRVANA, che è la dissoluzione di ogni falsità e l'unione finale con lo Spirito Divino Universale, giacchè ogni cosa ed ogni essere è destinato a passare, solo l'Essenza divina è eterna.
Le Quattro Nobili Verità
Gli insegnamenti del BUDDHA si possono riassumere in questi princìpi:
1-il dolore è universale; 2-la causa del dolore sta nei desideri egoistici; 3-il dolore si guarisce eliminando i desideri; 4-il modo di eliminare i desideri è la Via Media seguendo gli 8 nobili sentieri, simboleggiati dai raggi della Ruota della Dottrina. Seguendo questi sentieri si raggiunge il Nirvana ed essi consistono in questi precetti:
1-purezza di fede; 2-purezza di volontà; 3-purezza di linguaggio; 4-purezza d'azione; 5-purezza di vita; 6-purezza d'applicazione; 7-purezza di memoria; 8-purezza di meditazione
Per la migliore applicazione nella vita quotidiana di questi principi, i devoti del BUDDHA formularono Cinque Precetti, molto simili ai Comandamenti biblici:
1-non uccidere (questo precetto comprende il rispetto per la vita di tutti gli esseri viventi, non solo umani); 2-non rubare; 3-non commettere atti impuri; 4-non mentire; 5-non consumare bevande inebrianti.
Il pensiero del BUDDHA si può così riassumere:
Chi ha capito che tutte le cose create periscono e sono impermanenti, è libero dal dolore. Chi ha superato ogni attaccamento, resistito alle tentazioni, rinunciato ai desideri, è il più grande degli uomini. Il raggiungimento di queste condizioni fondamentali determina l'illuminazione spirituale; l'illuminazione spirituale suscita automaticamente il sentimento di compassione e il rispetto verso tutti gli esseri viventi. Nel BUDDISMO è fondamentale la capacità d'introspezione e, dunque, la conoscenza di sè stessi: delle proprie debolezze, della radice dei propri desideri e delle illusioni, di ciò che è autentico ed emerge dalla nostra profonda essenza e di ciò che, invece, proviene dall'esterno come induzione e convinzione deleteria che si oppone allo sviluppo interiore. L'illuminazione, la vera luce, proviene dall'interno, mediante la concentrazione, la meditazione e l'introspezione fino al raggiungmento del nucleo essenziale di noi stessi, incondizionato ed imperturbabile. Nel tempo, con l'applicazione su di sè di questi princìpi, l'apertura del TERZO OCCHIO, corrispondente al sesto chakra (quello della fronte), farà emergere il potere della chiaroveggenza e della percezione della realtà soprasensibile, ossia di mondi e dimensioni non accessibili alla coscienza ordinaria legata ai 5 sensi.
Gli occhi chiusi del Buddha come profonda visione interiore
Date queste premesse, possiamo ben comprendere il profondo significato dell'antica iconografia del BUDDHA, in cui viene generalmente ritratto come una figura seduta a gambe incrociate, in piedi o in posizione stesa, e quasi sempre con gli occhi chiusi. Gli occhi chiusi del BUDDHA possono essere considerati l'opposto simbolico degli occhi sbarrati con cui vennero raffigurate le divinità o i loro devoti in epoca arcaica (Mesopotamia), modello che poi venne ripreso in Occidente nella tarda antichità (paleocristiana e bizantina): gli occhi chiusi sono l'espressione della più profonda visione di ogni cosa, che non viene percepita nella sua apparenza esteriore ed illusoria, ma nella sua più intima essenza alla radice del suo apparire come fenomeno fisico o psicologico. Per questo motivo l'immagine degli occhi chiusi assume un senso molto più vivo ed essenziale di tutte le raffigurazioni dallo sguardo esterrefatto dell'antica iconografia sacra: queste ultime esprimono, infatti, una sorta di "possessione" da parte di una forza soprannaturale, che per questo motivo può avere un valore strumentalizzante più che simboleggiare una profonda consapevolezza; al contrario, gli occhi chiusi del BUDDHA manifestano la fonte stessa da cui la consapevolezza (intesa come sentimento d'unione con tutto il creato) emerge: l'interiorità umana. Prima di guardare fuori, dobbiamo guardare dentro, a quella dimensione infinita in cui sono riposte tutte le facoltà dell'anima, le capacità intuitive, percettive, contemplative; solo dopo il viaggio interiore possiamo veramente aprire gli occhi sul mondo con sentimento empatico e responsabile. Gli occhi chiusi rappresentano l'ascolto del cuore, la comprensione; in questo modo il BUDDHA potè raggiungere l'illuminazione sotto l'albero della Bodhi (Albero del Risveglio): un grande fico sacro nella terra di Bodhgaya. Il più delle volte il BUDDHA è raffigurato seduto a gambe incrociate; il BUDDHA dormiente e disteso rappresenta la fase del raggiungimento del NIRVANA. Come CRISTO subito dopo il battesimo si ritirò nel deserto della Giudea, il BUDDHA si ritirò dal mondo e praticò un periodo di vita ascetica prima di raggiungere l'illuminazione e decidere la diffusione della sua dottrina, fondando una linea di pensiero diversa da quella induista del suo tempo; allo stesso modo CRISTO si distanziò dalle caste sacerdotali dell'epoca per un più evoluto cammino spirituale. Questo ritiro indica la necessità di volgere lo sguardo all'interno prima di porre l'attenzione ai problemi del mondo, altrimenti ogni opera è vana e la volontà rimane priva di radici profonde nell'anima: allora il simbolismo degli occhi chiusi diviene superiore a quello degli occhi meravigliati delle iconografie arcaiche e tardo-antiche, poichè non vi è un "incontro" con l'essenza divina, ma una "creazione" precedente della stessa nell'interiorità umana.
IMMAGINE: Buddha seduto in un gesto di predicazione noto come "girare la ruota della dottrina". Pakistan settentrionale, forse Jamalgarhi, valle di Peshawar, ex regno di Gandhara. Datazione: 300-500 d.C. Materiale: scisto. Altezza: 86,4 centimetri. (Museo d'Arte Asiatica, San Francisco)
IMMAGINE: Statua di Buddha in bronzo dorato. Datazione: periodo T'ang, 618-907 d.C. Altezza: 20 centimetri. Il Buddha è seduto su una corolla di loto, con le mani compie il gesto della predicazione (dharmacakra-mudri). (New York, Metropolitan Museum)GLI "OCCHI SPIRITATI" NELL'ICONOGRAFIA DELL'ARTE BIZANTINA
Breve premessa storica
Dopo oltre mille anni, nel 330 d.C. la capitale dell'IMPERO ROMANO venne spostata da ROMA a BISANZIO, prendendo il nome di COSTANTINOPOLI (l'attuale Istanbul), poichè a decidere questo passaggio storico fu l'imperatore COSTANTINO. Spostare il fulcro del potere e del controllo da ROMA a COSTANTINOPOLI significava assumere una posizione molto più strategica nella difesa dei confini dell'IMPERO ROMANO: COSTANTINOPOLI, posta su un promontorio del ponte naturale fra il MARE EGEO e il MAR NERO, permetteva di tenere sotto controllo un passaggio fondamentale delle vie commerciali e di difendere i confini orientali dell'Impero. Con la morte di TEODOSIO, nel 395 d.C., l'Impero fu diviso in IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE e IMPERO ROMANO D'ORIENTE, con BISANZIO come capitale di quest'ultimo. Mentre l'IMPERO D'OCCIDENTE cadde nel 476 d.C. per mano del generale ODOACRE, stanziato in Italia, che guidò la rivolta dei popoli germanici e depose l'Imperatore ROMOLO AUGUSTOLO, l'IMPERO D'ORIENTE durò ancora più di mille anni. ODOACRE non volle trovare un successore di ROMOLO AUGUSTOLO, ma cercò di farsi riconoscere come Imperatore di RAVENNA (capitale dell'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE dal 402 al 476) dall'Imperatore di BISANZIO.
La parentesi iconoclasta
Fra l'VIII secolo e il IX secolo d.C. ci fu l'avvento dell'ICONOCLASTIA: un movimento religioso avverso alle raffigurazioni sacre, promosso da LEONE III l'ISAURICO, asceso al trono nell'anno 717. L'ideologia ICONOCLASTA affermava che l'utilizzo di immagini per idealizzare concetti o personaggi sacri deviasse l'attenzione dal vero culto dovuto a Dio, sfociando in una sorta di idolatria, facendo riferimento ai divieti del PENTATEUCO e dei DIECI COMANDAMENTI biblici. Le immagini artistiche erano considerate alla stregua di feticci e di distrazioni superstiziose. Nel 741 d.C., dopo la morte di LEONE III L'ISAURICO, gli ICONOCLASTI vennero definitivamente sconfitti. In particolare l'IMPERATRICE IRENE DI BISANZIO, che regnò dal 797 all'802, venne proclamata Santa per aver sconfitto l'ICONOCLASTIA riconducendo all'unità il mondo cristiano. Iconoclasta fu in seguito anche il movimento puritano inglese nato nel XVI secolo e il Calvinismo, ma questa è un'altra storia.
Nel VI secolo d.C, l'IMPERATORE GIUSTINIANO I di COSTANTINOPOLI (482-565) liberò l'Italia dagli OSTROGOTI, l'Africa dai VANDALI e la Spagna dai VISIGOTI, riuscendo quasi a ricompattare l'unità dell'IMPERO ROMANO. GIUSTINIANO fu l'ultimo Imperatore di lingua ed educazione latina della capitale orientale, affiancato dalla moglie, l'IMPERATRICE TEODORA. Tuttavia, l'estensione dell'IMPERO D'ORIENTE in Italia durò pochissimo, dal 553 al 568 d.C.; da questo momento, i LONGOBARDI, guidati da ALBOINO, dalla PANNONIA (fra Austria e Ungheria) scesero in Italia istituendo un regno, il REGNO LONGOBARDO, che durò dal 568 al 774 d.C. con l'ultimo Re DESIDERIO che venne sconfitto a Pavia da CARLO MAGNO. Il REGNO LONGOBARDO ebbe come capitale PAVIA e il suo dominio si estendeva fino a BENEVENTO. Nel IX secolo i SARACENI conquistarono il sud Italia con la conquista della Sicilia bizantina con lo sbarco, nell'827, a Mazara del Vallo. Nonostante fossero proclamati BASILEUS TON ROMAION (Re dei Romani) gli imperatori bizantini, nel tempo, vennero ad assumere i caratteri autoritari dei sovrani orientali, esercitando un potere assoluto in modo che il popolo si trasformò in una moltitudine di sudditi. L'Imperatore veniva considerato pari agli stessi Apostoli, divenendo una sorta di Re-Sacerdote a cui anche il Patriarca della Chiesa d'Oriente era sottomesso. Nacque così una forma religiosa alle dipendenze del potere imperiale. Nell'VIII secolo d.C., SERBI, CROATI e BULGARI tentarono di invadere i territori bizantini, venendo comunque ricacciati e, per mezzo dell'invio di missionari, ben presto convertiti al CRISTIANESIMO. Nel X secolo, il principe russo VLADIMIRO I di Kiev sposò una principessa bizantina, ANNA PORFIROGENITA, si convertì al CRISTIANESIMO e lo diffuse in tutto il suo regno.
Aspetti dell'architettura e dell'arte bizantina
Basilica di Santa sofia a Costantinopoli
L'ARCHITETTURA BIZANTINA seppe amalgamare sapientemente canoni romani, greci ed orientali, specialmente negli edifici religiosi, ma anche nei sontuosi palazzi dei sovrani, con elementi impreziositi con oro, pietre preziose e marmi pregiati. Una delle più antiche basiliche bizantine è SANTA SOFIA di COSTANTINOPOLI (Istambul), il cui primo nucleo venne costruito sotto l'Imperatore FLAVIO GIULIO COSTANZO, o COSTANZO II (317-361 d.C.), figlio di COSTANTINO I IL GRANDE. Venne consacrata dal vescovo EUDOSSIO DI ANTIOCHIA e fu innalzata nei pressi del Palazzo Imperiale. Più antica è la vicina chiesa di SANTA IRENE, che fino ad allora era la chiesa principale. Durante la sua costruzione SANTA SOFIA venne distrutta ben due volte a causa di rivolte popolari: nel 404, quando venne ricostruita e inaugurata da TEODOSIO II (Imperatore dal 408 al 450) nel 415, e nel 532 durante la sommossa di Nika contro l'Imperatore GIUSTINIANO I IL GRANDE: in quest'ultimo caso la chiesa venne completamente incendiata. Dopo questo episodio, GIUSTINIANO e la moglie TEODORA decisero di costruire una nuova basilica e di renderla più grande e più maestosa di tutte le versioni precedenti, ad opera dell'architetto ISIDORO DI MILETO e del matematico ANTEMIO DI TRALLE. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: colonnati greci, la più grande cupola del mondo fino alla costruzione della BASILICA DI SAN PIETRO a ROMA: il suo diametro è di 32 metri, decorata con motivi geometrici; incantevoli mosaici sulle volte e sulle pareti che ritraggono santi, immagini di CRISTO, dei PADRI DELLA CHIESA, scene dei VANGELI. Vista dall'esterno, SANTA SOFIA ha un aspetto imponente e massiccio; si dice che alla sua costruzione abbiano lavorato più di 10.000 operai per sei anni; al suo interno c'è la tomba di ENRICO DANDOLO, DOGE di VENEZIA (1107-1205), morto a COSTANTINOPOLI.
"E si vede in questa levato via il proffilo che ricigneva per tutto le figure, e quegli occhi spiritati e’ piedi ritti in punta e le mani aguzze et il non avere ombre et altre mostruosità di que’ Greci". (GIORGIO VASARI, "Le vite de' più eccellenti pittori, scultori et architettori", 1550)
Il pesante giudizio di GIORGIO VASARI sull'arte bizantina alla metà del '500 trovò una larga eco anche nei secoli successivi; dobbiamo giungere fino al NEOCLASSICISMO, che si sviluppò alla metà del XVIII secolo, per un riconoscimento del suo valore artistico, soprattutto per il merito di aver tramandato il patrimonio dell'antichità. Se vogliamo definire l'ARTE BIZANTINA in poche parole, possiamo dire che essa vuole rappresentare l'incorruttibilità e la vittoria sulla morte, la pura astrazione spirituale delle forme e dei soggetti dalla tirannia del tempo e della ciclicità, in uno spazio in cui l'anima trova la sua emancipazione fra i riflessi dorati che prefigurano il raggiungimento della dimensione divina. I grandi occhi dilatati della tradizione iconografica bizantina hanno lo scopo di rappresentare l'influsso della dimensione ultraterrena, ammaliando l'osservatore con il loro potere magnetico e il loro apparire come dei grandi "buchi neri", dei portali da cui si accede a un superiore stato di coscienza. Questo canone era già stato utilizzato nei ritratti di EL FAYUM e nell'ARTE PALEOCRISTIANA, che anticipò l'orientamento artistico BIZANTINO. L'accentuazione dello sguardo nell'ARTE BIZANTINA ha l'aspetto di una reminiscenza connessa alle rappresentazioni arcaiche di millenni più antiche nell'area mediorietale, di cui abbiamo trattato precedentemente. Lo SGUARDO BIZANTINO così diviene il fulcro dell'iconografia umana, a cui fanno da cornice i volti più o meno stilizzati e le figure intere senza peso dei personaggi, che levitano in una dimensione mistica, circonfusa di immensi spazi d'oro o di scenari bidimensionali, nel tentativo di evocare il superamento della materia proprio attraverso la liberazione di quest'ultima dalla corruzione terrena nel modello fisso dell'immagine. In questo modo i piedi dei personaggi si sovrappongono, come nel mosaico di GIUSTINIANO I e la sua corte a SAN VITALE, RAVENNA (datato 547 d.C.), così come ogni elemento sembra racchiuso in una propria bolla, isolato da tutto il contesto e privo di peso.
I mosaici di Santa Sofia a Costantinopoli
I mosaici presenti nella basilica di SANTA SOFIA non sono quelli originali dell'epoca in cui fu costruita (317-361 d.C.), a causa della febbre iconoclasta dell'Imperatore LEONE III ISAURICO che con un editto del 726 li fece rimuovere. I mosaici più antichi che oggi si possono ammirare risalgono al IX secolo. Il mosaico absidale della cupola centrale del fondo (fra le 13 cupole del complesso) ritrae una MADONNA CON BAMBINO dallo sguardo malinconico, abbigliata con un abito blu dimesso e assisa su un cuscino; il bambino accenna un sorriso, è biondo con un volto pieno e gioioso, purtroppo l'occhio sinistro è danneggiato. Gli occhi obliqui, assenti e oltremodo tristi di questa MADONNA, contrastano con l'espressione gioconda del BAMBINO; le due figure campeggiano in mezzo al vuoto dorato dell'abside. La CUPOLA principale è suddivisa in 4 sezioni in cui compaiono schiere di angeli e santi in campo d'oro, più altre due sezioni verso l'apertura centrale con decorazioni geometriche; una grande immagine di CRISTO a figura intera è attorniata dalle immagini mistiche dell'intero ciclo musivo. Colpisce particolarmente l'immagine di uno dei 4 SERAFINI posti su ogni lato della struttura: un volto umano racchiuso fra 6 ali che coprono completamente il resto della fgura intera; gli occhi sono vicini, non esageratamente grandi e guardano direttamente l'osservatore con un'espressione imperturbabile. La figura di questo angelo e degli altri 3 è attinente con le strane forme della descrizione biblica delle apparizioni angeliche; le dimensioni sono di circa 3 metri.
IMMAGINE: mosaico di Madonna con Bambino, basilica bizantina di Santa Sofia, Costantinopoli. Datazione: IX secolo. Dimensioni: assenti, ma potrebbe approssimativamente raggiungere più di 2 metri d'altezza.
IMMAGINE: mosaico di Cristo benedicente con il gesto del "prithvi mudra" indiano, ma di origini molto più antiche: l'anulare rappresenta la terra, il pollice il fuoco spirituale e, dunque, l'unione dello Spirito Santo con la Terra. Basilica bizantina di Santa Sofia, Costantinopoli. Dimensioni: assenti.IMMAGINE: uno dei 4 Serafini posti su ogni lato dell'edificio, con 6 ali e lo sguardo rivolto all'osservatore, unico dettaglio visibile della sua figura intera completamente coperta dalle ali. Basilica di Santa Sofia, Costantinopoli. Datazione: IX secolo. Dimensioni: circa 2 metri e mezzo.
Lo sguardo nell'arte bizantina italiana
Contesto storico
La dominazione bizantina in Italia durò pochissimo, dal 553 al 568 d.C; l'esercito bizantino sbarcò in SICILIA nel 535 e da lì ebbe inizio una dura lotta per la riconquista della penisola durata fino alla stabilizzazione del potere nel 553. Il Re degli OSTROGOTI, TEODORICO IL GRANDE (454-526 d.C.), conquistò RAVENNA nel 493. In seguito al trattato di pace stipulato fra COSTANTINOPOLI e le tribù germaniche degli OSTROGOTI, stanziate nella regione della PANNONIA (fra Austria e Ungheria, sul Danubio), all'età di circa 7 anni TEODORICO venne inviato, come garanzia di fedeltà al trattato, dal padre TEODEMIRO a COSTANTINOPOLI, al tempo sotto l'Imperatore LEONE I. TEODORICO potè così ricevere un'ottima istruzione presso la Corte Imperiale. Ben presto TEODORICO venne rimandato a casa da LEONE I, quando ormai gli OSTROGOTI si dimostravano innocui; alla morte del padre, nel 474, divenuto sovrano degli OSTROGOTI, TEODORICO avviò numerose spedizioni contro i nemici dell'IMPERO BIZANTINO e ciò gli permise di conquistare prestigio alla Corte Imperiale di COSTANTINOPOLI. In seguito si verificarono numerosi conflitti e tensioni fra TEODORICO e il nuovo Imperatore bizantino ZENONE, poichè quest'ultimo non fece ulteriori concessioni al sovrano OSTROGOTO, per timore che il suo regno divenisse troppo potente. All'avvento di nuove sommosse però, l'Imperatore ZENONE si vide costretto a venire a patti con TEODORICO, promuovendolo MAGISTER MILITUM (capo dell'esercito), ma questo non placò il risentimento di TEODORICO che continuò a minacciare l'IMPERO BIZANTINO fino alla stessa COSTANTINOPOLI. Per risolvere questo problema, ZENONE propose a TEODORICO il governo dell'Italia, all'epoca sotto il dominio del generale germanico ODOACRE, in qualità di PATRIZIO (massimo titolo nobiliare). Ben presto, dunque, TEODORICO organizzò le spedizioni contro ODOACRE, non senza difficoltà e sconfitte, fino all'invio di aiuti militari da parte del Re dei VISIGOTI, ALARICO II, che gli permisero di dominare, infine, l'intera penisola. ODOACRE, dal canto suo, rimaneva assediato nella città di RAVENNA e, dopo lunghe trattative, nel 493, il VESCOVO DI RAVENNA, GIOVANNI, riuscì a trovare un'intesa fra i due sovrani, secondo la quale avrebbero dovuto governare insieme. Tuttavia, TEODORICO tradì la parola data, uccidendo pochi giorni dopo ODOACRE ad un banchetto; non pago di ciò, TEODORICO fece assassinare anche moglie, fratello e figli del rivale. Il Regno di TEODORICO si protrasse sotto il segno della convivenza religiosa fra cattolici, ebrei e culto ARIANO a cui egli apparteneva. Dal 535 al 553 l'IMPERATORE GIUSTINIANO conquista l'Italia sconfiggendo il Regno degli OSTROGOTI e nel 540 RAVENNA fu trasformata in un esarcato dell'IMPERO D'ORIENTE. GIUSTINIANO aconfisse altresì i PERSIANI sul confine orientale, i VANDALI sulle coste dell'Africa e in Sardegna, i VISIGOTI in Spagna.
Quadro ideologico dell'Arianesimo
Ma facciamo di nuovo un passo indietro, al regno di TEODORICO IL GRANDE (454-526 d.C.). TEODORICO istituì RAVENNA come sede del suo Palazzo, costruendo accanto la chiesa di SANT'APOLLINARE NUOVO, in cui si celebrava il CULTO ARIANO. L'ARIANESIMO fu uno dei più grandi conflitti ideologici dell'antico CRISTIANESIMO. Prende il nome da un presbitero di ALESSANDRIA, ARIO (256-336); nato nel 256 d.C., ARIO ricevette un'educazione teologica alla scuola del dotto LUCIANO D'ANTIOCHIA (235-312), a sua volta discepolo di PAOLO DI SAMOSTATA (200-275). L'ARIANESIMO, in opposizione al dogma cattolico, affermava la non-consustanzialità di Dio Padre e Figlio, negando il concetto stesso di TRINITA', cioè la sussistenza di tre soggetti distinti tra loro, essendo lo SPIRITO SANTO anch'esso generato; in questo modo, il Figlio nella persona di CRISTO e lo stesso LOGOS non possono essere Dio, ovvero l'essenza divina in tre parti distinte, ma lo stesso GESU' CRISTO si riduce a qualcosa di creato, sebbene più perfetto e superiore ad ogni altro essere umano, eppure non consustanziale a Dio. In seguito a numerose dispute dottrinali, nel 325 il CONCILIO DI NICEA, convocato dall'Imperatore COSTANTINO I in accordo con il Vescovo di ROMA, SILVESTRO I, condannò come dottrina eretica l'ARIANESIMO, stabilendo la formula secondo la quale Dio Padre e il Figlio erano sostanzialmente identici, consustanziali, essendo GESU' CRISTO diretta manifestazione divina nel mondo e, quindi, ogni concetto di "creazione del Figlio" da parte del Padre (e quindi di riduzione di Cristo stesso a semplice creatura o strumento) venne rifiutato. Paradossalmente, l'ARIANESIMO, sconfitto entro i confini dell'IMPERO BIZANTINO, trovò terreno fertile presso le popolazioni germaniche che ne fecero un elemento di distinzione dalla cultura romana. All'ARIANESIMO si convertirono i GOTI, BURGUNDI, SVEVI, VANDALI e LONGOBARDI.
RAVENNA
Il breve lasso di tempo del dominio bizantino in Italia ha permesso la diffusione dei suoi canoni con la realizzazione di grandiose opere, concentrate soprattutto a RAVENNA, con la BASILICA DI SAN VITALE (terminata nel 547), la BASILICA DI SANT'APOLLINARE IN CLASSE (edificata per volere del vescovo URSICINO, consacrata nel 549), la CHIESA DI SAN MICHELE IN AFRICISCO (anno 545). La BASILICA DI SANT'APOLLINARE NUOVO, il BATTISTERO DEGLI ARIANI, costruito quando l'ARIANESIMO era dottrina ufficiale di corte (anno 493), anch'esso con la cupola rivestita di mosaici; la CAPPELLA DI SANT'ANDREA, all'interno del complesso del PALAZZO ARCIVESCOVILE, BATTISTERO NEONIANO, che prende il nome dal Vescovo NEONE, terminato alla metà del V secolo ed è perciò uno dei monumenti in stile bizantino più antichi di RAVENNA; il più antico è la CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA, paleocristiana, consacrata nel 425. Il piccolo MAUSOLEO DI GALLA PLACIDIA (386-450), che fu grande mecenate e figlia dell'Imperatore TEODOSIO I (347-395).
Gli sguardi nei ritratti bizantini di Ravenna
Fra i capolavori musivi di SAN VITALE a RAVENNA ci sono i cortei di GIUSTINIANO (545 d.C.; dimensioni: 421 x 280 cm.) e della moglie TEODORA (idem); la coppia imperiale è raffigurata assieme al suo seguito mentre offrono il pane e il vino eucaristico; accanto all'Imperatore GIUSTINIANO c'è il vescovo di COSTANTINOPOLI, MASSIMIANO, che regge una croce dorata con gemme preziose. I volti dei personaggi con le tuniche bianche sono fortemente individualizzati, dei veri e propri ritratti estremamente naturali purchè soggetti alle restrizioni tecniche del mosaico. I loro sguardi sono severi, ma non esageratamente, li possiamo definire dignitosi e attenti. L'Imperatore GIUSTINIANO presenta tratti naturalistici, nei limiti del possibile; il suo volto è giovanile, con mento pronunciato e guance piene; gli occhi sono più grandi del naturale e ben delineati, marroni con pupilla, con sopracciglia leggermente aggrottate. L'Imperatrice TEODORA nel mosaico è simile altre sue raffigurazioni scultoree: collo lungo, carnagione bianca, viso ovale, acconciatura pesante di tipo orientale, occhi color nocciola con pupilla; il suo sguardo è più sereno, le sopracciglia appena accennate; l'artista ha voluto accenturare le ombreggiature sotto gli occhi per aggiungere intensità allo sguardo, riuscendoci perfettamente! Sulla cupola del BATTISTERO DEGLI ARIANI (fine del V secolo), nel tondo centrale incorniciato da una schiera di 12 santi, abbiamo il BATTESIMO DI CRISTO, alla sua destra San GIOVANNI BATTISTA, alla sua sinistra la personificazione del fiume GIORDANO, con le chele di granchio sulla testa tipiche delle divinità acquatiche; sopra la sua testa discende lo SPIRITO SANTO sotto forma di colomba. Il corpo nudo del CRISTO è piuttosto adiposo, quasi femmineo, ma ben proporzionato e armonioso; anche il volto presenta tratti ambigui e i grandi occhi marroni sono delineati con particolare accuratezza, con l'ombreggiatura inferiore e le sopracciglia distese a indicare uno sguardo sereno e distante. Nella basilica di SANT'APOLLINARE IN CLASSE, fra il ricco patrimonio musivo che ricopre absidi e pareti al suo interno, compresa la grande raffigurazione di SANT'APOLLINARE in un contesto paradisiaco di greggi e vegetazione, spicca soprattutto un busto di CRISTO benedicente fra i simboli degli EVANGELISTI: il leone per SAN MARCO, l'angelo per SAN MATTEO. GESU' CRISTO è raffigurato a mezzo busto, con in mano un libro come simbolo della parola di Dio nel mondo; il volto è quello di un uomo maturo, che non corrisponde alla giovane età in cui CRISTO è morto; dai tratti molto individuali sembra che l'artista abbia preso a modello una persona reale. Infatti, non ci troviamo di fronte al consueto volto aggraziato e impersonale, con naso sottile e labbra piccole e ben delineate: il naso ha linee forti ed è leggermente aquilino, ma è negli occhi che l'artista ha messo particolare cura, delineando uno sguardo dilatato e attento, con iride color nocciola e pupilla ritirata come quando ci si trova d fronte ad una grande fonte luminosa. Le sopracciglia sono delineate in modo da sollevarsi leggermente ai lati con l'effetto di un'espressione meravigliata; i segni inferiori delle occhiaie, arricchiti da un cerchio bianco simile ad un occhiale, vi aggiungono un tocco passionale ed amplificano ancor di più l'effetto ipnotico dell suo sguardo. Il clipeo circolare in cui è racchiusa l'immagine, inoltre, non è d'oro, ma riprende la stessa tonalità rosea dell'incarnato, come a voler espandere l'essenza cristica oltre la sua immagine.
IMMAGINE: dettaglio con il volto dell'Imperatore Giustiniano nel mosaico precedente. Datazione: 545 d.C. Basilica di San Vitale, Ravenna.
IMMAGINE: L'Imperatore Giustiniano e la moglie Teodora (foto appaiate), mosaici della basilica di San Vitale, Ravenna. Datazione: 545 d.C.
IMMAGINE: L'Imperatrice Teodora e il suo seguito, mosaico della basilica di San Vitale, Ravenna. Datazione: 545 d.C.
IMMAGINE: Cristo benedicente, mosaico della basilica di Sant'Apollinare in Classe, Ravenna. Datazione: 549 d.C.IMMAGINE: mosaico con figura di profeta, Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna. Datazione: VI secolo.
IMMAGINI: mosaico con il battesimo di Criso, cupola del Battistero degli Ariani, Ravenna. Datazione: 493 d.C.
SICILIA - cenni generali
MONREALE, in Sicilia, è un'altra delle più importanti città con capolavori d'arte bizantina: il DUOMO DI MONREALE, costruito nel 1172 per volere del Re di Sicilia GUGLIELMO II D'ALTAVILLA (1153-1189). Vi è poi il PALAZZO REALE e la CAPPELLA PALATINA a PALERMO, consacrata nel 1140 e costruita per volere del Re RUGGERO II IL NORMANNO, della dinastia degli ALTAVILLA. RUGGERO D'ALTAVILLA salì al trono del REGNO DI SICILIA nel 1130 e si trovò a governare un territorio composito, dovendo gestire la convivenza di cristiani di rito cattolico e greco, musulmani ed ebrei, guardando a COSTANTINOPOLI come principale punto di riferimento culturale ed artistico; nella CHIESA DELLA MARTORANA, a PALERMO, fra gli altri splendidi mosaici, c'è n'è uno che ritrae il Re che riceve la corona da CRISTO stesso. Sempre RUGGERO II fu committente del DUOMO DI CEFALU', con ricchi mosaici al suo interno. La Chiesa di SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO a PALERMO fu edificata nel 1143 da GIORGIO DI ANTIOCHIA, ammiraglio di re RUGGERO II.
Gli occhi velati di tristezza Cristo Pantocratore nell'abside del duomo di Monreale
Nell'abside del duomo di MONREALE abbiamo il mosaico con la gigantesca immagine di CRISTO PANTOCRATORE, realizzato fra il 1180 e il 1190, che misura 13 x 7 metri, talmente imponente che le piccole tessere di cui è formato danno l'effetto della pittura. La mano destra è alzata in segno di benedizione, nella sinistra regge un libro su cui è scritto:
“Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre”.
Anche in questo caso si vede il volto di un uomo maturo, ma privo di connotazioni individuali; lo sguardo è indefinibile, languido e assorto, non rivolto verso l'osservatore. Le sopracciglia non sono esageratamente marcate ed arcuate, ma lineari, mentre gli occhi castani sono delineati dalle ombreggiature, l'inclinazione verso il basso dona allo sguardo una velatura triste. Il gesto che è presente in quasi tutte le raffigurazioni di CRISTO benedicente, ossia dell'unione fra anulare e pollice mentre il resto della mano rimane aperto, è simile a quello del MUDRA indiano ed ha origini molto antiche; secondo la tradizione ogni dito della mano corrisponde ad un elemento: pollice-fuoco, indice-aria, medio-etere, anulare-terra, mignolo-acqua; ecco che allora il gesto cristico viene a rappresentare l'unione del fuoco spirituale con la terra, indicando la doppia natura umana e divina di CRISTO.
VENEZIA - cenni generali
A VENEZIA la BASILICA DI SAN MARCO è emblema della fusione di diversi stili: GOTICO, BIZANTINO, ROMANICO. E' la cattedrale della città e fu sede del Patriarcato, la costruzione venne iniziata nell'828 e terminata nell'832. Ma la prima versione della basilica venne distrutta da un devastante incendio; nel 1063 iniziano i lavori per la sua ricostruzione su commissione del DOGE DOMENICO CONTARINI (30° doge della REPUBBLICA DI VENEZIA). La basilica viene progettata da architetti di COSTANTINOPOLI, secondo un piano grandioso che supera per dimensioni ogni altra costruzione bizantina esistente all'epoca in Italia: la pianta è a croce greca e ogni suo braccio è suddiviso in tre navate da colonne, con quattro enormi cupole che sovrastano ogni estremità della croce, ricoperte da mosaici in campo d'oro dall'impatto visivo grandioso. A MURANO, isola veneziana, c'è la bizantina BASILICA DEI SANTI MARIA E DONATO, costruita nel VII secolo e rifatta completamente nel XII secolo; sull'abside domina solitaria la figura intera della MADONNA ORANTE su un vasto campo d'oro vuoto; vi sono poi i mosaici pavimentali datati al 1141.
Gli sguardi nel mosaico del bacio di Giuda nella basilica di San Marco
Generalmente, le raffigurazioni musive che ricoprono tutto l'interno della BASILICA DI SAN MARCO a VENEZIA sono abbastanza convenzionali, geometrizzate e prive di volume, come nel mosaico del bacio di GIUDA, risalente al XIII secolo: qui lo sguardo di CRISTO rimane impassibile di fronte al gesto traditore, mentre quello di GIUDA lascia trapelare un'espressione sdolcinata; i volti degli altri personaggi hanno sguardo compassionevole e malinconico, accentuato dalle pesanti ombreggiature.IMMAGINI: mosaico con la scena del bacio di Gouda, basilica di San Marco, Venezia. Datazione: XIII secolo.
ROMA- cenni generali
La PORTA BIZANTINA di San Paolo fuori le mura fu il primo portale d'ingresso della BASILICA DI SAN PIETRO in VATICANO, oggi è posta nel lato interno della PORTA SANTA ed è datata al 1070, secondo le iscrizioni; è stata portata a ROMA da COSTANTINOPOLI su committenza di PANTALEONE DI AMALFI e dell'arcidiacono ILDEBRANDO DI SOANA (futuro Papa GREGORIO VII). E' composta da 54 formelle di bronzo raffiguranti scene dell'Antico e Nuovo Testamento. La BASILICA DI SANTA PUDENZIANA, fondata nel IV secolo, ma completata nel 1588; il grande mosaico dell'abside con CRISTO e gli APOSTOLI risale al 390 e si narra che fu costruito sopra l'abitazione di PUDENTE, senatore romano che ospitò SAN PIETRO quando giunse a ROMA. La BASILICA DI SAN PRASSEDE, iniziata nell'VIII secolo e terminata nel IX secolo, ospita anch'essa splendenti mosaici sulle pareti e sull'abside del presbiterio con le figure di CRISTO e santi in campo blu; inoltre, il mosaico della MADONNA con BAMBINO, icone di SANTA PRASSEDE e dell'episcopa TEORDORA. La BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE, fra le 4 basiliche papali a ROMA, iniziata nel 432, venne riccamente ornata di mosaici già nel V secolo, sotto Papa SISTO III (44° vescovo di Roma dal 432 al 440); il ciclo di mosaici, lungo fino a cento metri, come testimonianza più antica del monumento, campeggia grandioso sull'arco trionfale con la raffigurazione delle storie dell'infanzia di CRISTO, datato dal 432 al 440, sulle navate e sugli absidi. La BASILICA DEI SANTI COSMA E DAMIANO, luogo di culto nella zona del FORO ROMANO, è fra le più antiche chiese cristiane di ROMA, costruita sulle fondamenta di edifici pubblici d'epoca romana; nel 526 Papa FELICE IV venne autorizzato da Re TEODORICO a costruire la basilica che venne dedicata ai santi COSMA e DAMIANO, due fratelli medici che si rifiutarono di fare sacrifici alle divinità pagane e vennero uccisi per ordine del prefetto romano della CILICIA, distretto imperiale in ASIA MINORE; le loro reliquie furono condotte a ROMA e sistemate in questa basilica. L'abside è decorato con un mosaico di CRISTO in mezzo ai due santi. BASILICA DI SANTA MARIA TRASTEVERE, iniziata nel IV secolo in stile romanico, decorata con mosaici risalenti ai tempi di PAPA INNOCENZO II, realizzati dal 1130 al 1143; il magnifico mosaico absidale, in particolare, è costellato di simbologie e allusioni esoteriche.
I grandi occhi castani dei santi Cosma e Damiano a Roma
Nella basilica di COSMA E DAMIANO, a ROMA, l'abside centrale è decorato con un grande mosaico, fra i più antichi della capitale, risalente al VI secolo, coevo alla costruzione dell'edificio e alto circa 4 metri: raffigura i santi COSMA e DAMIANO, due gemelli medici romani "anagiri", che cioè prestavano servizio gratuitamente, martirizzati in Siria nel 303 sotto l'Imperatore DIOCLEZIANO (un'altra fonte afferma che ciò sia avvenuto in Cilicia, Asia Minore) perchè si rifiutarono di sacrificare agli dèi. Nel mosaico c'è la figura di CRISTO sulle nubi sospeso in un grande cielo blu; ai suoi piedi il fiume GIORDANO. Lo scenario evoca un luogo paradisiaco, con piante, prati verdi e palme. Nella fascia sottostante i sei agnelli su ogni lato rappresentano gli APOSTOLI. COSMA e DAMIANO sono raffigurati su tutti e due i lati, in modo speculare mentre porgono la corona regale a CRISTO; sul lato destro dell'osservatore SAN PIETRO presenta SAN DAMIANO a CRISTO; sul lato sinistro SAN PAOLO presenta al Signore SAN COSMA; all'estremità sinistra PAPA FELICE mostra un modellino della basilica realizzata da lui; all'estremità destra SAN TEODORO porta una corona. I gemelli sono ritratti identici, con caratteristiche molto marcate, grandi occhi castani con sopracciglia leggermente aggrottate e sguardo dilatato; quest'accentuazione dello sguardo si ripete anche sui volti degli altri personaggi e la loro espressione è generalmente imperturbabile.
MILANO - cenni generali
MILANO fu capitale dell'IMPERO ROMANO D'OCCIDENTE dal 379 e il 402. A MILANO abbiamo la BASILICA DI SANT'AMBROGIO, di architettura romanica-paleocristiana, consacrata nel 379, sul cui abside vi è un mosaico opera di artisti bizantini del IX secolo: raffigura CRISTO REDENTORE fra due angeli e figure di santi in campo d'oro. La BASILICA DI SAN LORENZO venne innalzata a cavallo fra il IV e il principio del V secolo; nonostante la data di fondazione sia ancora incerta, era sicuramente già costruita nel 513, data riportata in uno scritto del VESCOVO di PAVIA per celebrare la costruzione della CAPPELLA DI SAN SISTO; un mosaico del V secolo campeggia sull'abside della CAPPELLA DI SANT'AQUILINO, che si trova nella parte destra della basilica; il mosaico raffigura CRISTO fra gli APOSTOLI, con vesti bianche in campo d'oro. La basilica paleocristiana DI SAN NAZARO IN BROLO, consacrata nel 386. La BASILICA VIRGINUM, anch'essa paleocristiana, iniziata nel IV secolo.
Lo sguardo assente e "silenzioso" di San Vittore in Ciel d'Oro
Nella BASILICA DI SANT'AMBROGIO a MILANO, fra gli altri capolavori musivi c'è quello di SAN VITTORE IN CIEL D'ORO, risalente alla seconda metà del V secolo: il ritratto del santo è raffigurato a mezzo busto sulla cupola del sacello, racchiuso in un clipeo con decorazioni che rappresentano le stagioni, fra cui una fiamma sopra il suo capo. L'aspetto è quello di un uomo di mezza età, con capelli grigi; i tratti del volto, ovale e con orecchie grandi ma non esageratamente, sono molto individuali: il suo sguardo è assente e gli occhi non presentano caratteristiche stilizzate, ma hanno proporzioni ed espressione naturale e rilassata; anche la bocca, chiusa sotto i baffi, è resa con una linea naturalistica. Sulle due croci che regge ci sono le iscrizioni con i nomi dei committenti: "Paneciriae" e "Faustini". Sul libro aperto il suo nome: "Victor". Il grande vuoto dorato della cupola, con la centro il volto silenzioso e tranquillo del santo, trasmette un grande senso di pace interiore e trascendente.
IMMAGINE: mosaico di San Vittore in Ciel d'Oro, basilica di Sant'Ambrogio, Milano. Datazione: seconda metà del V secolo d.C. Descrizione nel paragrafo qui sopra.
L'ICONA DI CRISTO PANTOCRATORE DEL SINAI
IMMAGINE: Icona di Cristo Pantocratore dal monastero ortodosso di Santa Caterina del Sinai, Egitto. Altezza: 84 centimetri. Tecnica: tempera ad encausto su tavola. Datazione: VI secolo d.C. E' la più antica immagine esistente di Cristo Pantocratore. Lo stile artistico si ricollega a quello dei ritratti del Fayyum. L'evidente assimmetria del volto può avere molti significati: la metà alla nostra sinistra presenta un'espressione serena, aperta e distesa; l'altra metà sembra non combaciare perchè appare turbata, con un sopracciglio un po' aggrottato, l'occhio che osserva più in basso rispetto a quello sinistro che guarda di fronte; sempre a destra, un lieve solco fa assumere una piega amara alla bocca. Una delle interpretazioni potrebbe riguardare la parabola del ritorno del Cristo (Matteo, 25), in questo modo l'occhio alla nostra sinistra sarebbe quello del buon pastore che osserva coloro che hanno fatto la volontà di Dio, l'occhio alla nostra destra quello del giudice verso i corrotti. Un'altra interpretazione potrebbe riguardare il passaggio dalla sofferenza alla resurrezione. Santa Caterina del Sinai, in Egitto, è uno dei monasteri più antichi della cristianità, risalente al VI secolo e costruito ai piedi del Monte Sinai, in mezzo ad un deserto roccioso. E' dedicato al culto greco-ortodosso e oggi ci vivono 20 monaci. Contiene più di 2000 icone bizantine, un grande mosaico con la trasfigurazione di Cristo e la più grande biblioteca cristiana con oltre 6000 manoscritti, seconda solo a quella del Vaticano.
LO SGUARDO MISTICO DELLE STATUE DEL TEMPIETTO LONGOBARDO DI CIVIDALE
Cenni storici
I GERMANI, ai tempi dell'antca Roma, erano stanziati nell'Europa centrale, sulle rive del Reno, del Danubio, della Vistola, dell'Elba. A partire dal II secolo d.C. iniziarono a fare irruzione sulla penisola italiana, violando i confini dell'IMPERO ROMANO. Nel VI secolo d.C. quasi tutti i popoli germanici avevano, in parte, subito l'influenza della cultura romana; uno dei gruppi che conservarono le proprie tradizioni e istituzioni ataviche era quello del LONGOBARDI, così denominati per le lunghe barbe ("langbarte"), o forse per le lunghe lance da guerra (hallbart=alabarda). I LONGOBARDI erano devoti al culto di ODINO, dio delle tempeste e della saggezza, suprema divinità della mitologia norrena; avevano abitazioni di legno con tetto di paglia recintate da uno steccato. Gli oggetti costituivano lo stretto necessario per vivere: una macina per il grano, pentole di rame o terracotta, corni che venivano usati come bicchieri, ecc...e ovviamente i crani dei nemici uccisi in battaglia appesi alle pareti. Nel 568 d.C., quasi 250.000 LONGOBARDI, compresi in tal numero i membri delle famiglie, sotto la guida del Re ALBOINO (530-572 d.C.) scesero dall'Ungheria verso l'Italia fondando un regno nella parte settentrionale (detto LONGOBARDIA) che alla morte di ALBOINO, nel 572, comprendeva tutto il territorio dalla Lombardia al Friuli. Il FRIULI fu il primo avamposto del regno dei ALBOINO, posto sotto la supervisione di GISULFO, comandante militare e primo duca della regione. Il DUCATO DEL FRIULI ebbe come capitale CIVIDALE, che al tempo dei Romani era detta FORUM IULII. Subito dopo la morte di ALBOINO, i duchi elessero Re CLEFI, che compì molte conquiste estendendo il regno a Toscana ed Emilia. In seguito, dopo un decennio di anarchia fra i molti ducati, nel 584 i duchi stessi elessero Re AUTARI, che respinse l'avanzata dei FRANCHI e conquistò le restanti città settentrionali, spodestando parte dei possedimenti dei duchi in modo che il suo potere non fosse minacciato. AUTARI prese in moglie la cattolica TEODOLINDA, figlia del duca germanico di BAVIERA; nel 590 il Re morì senza discendenza, lasciando alla moglie le redini del regno; TEODOLINDA si risposò con il duca di Torino, AGILULFO, che tentò di conquistare a sud i territori bizantini e il Ducato Romano (sotto l'IMPERO BIZANTINO) nel quale risiedeva Papa GREGORIO MAGNO, che fu costretto a pagare una considerevole somma per di difendere Roma dall'invasione longobarda. Durante il regno di ALBOINO (circa 568) i LONGOBARDI aderirono all'ARIANESIMO (forma eretica del Cristianesimo che rinnegava la Trinità divina), ma la Regina TEODOLINDA utilizzò la propria grande influenza per diffondere il CATTOLICESIMO fra la popolazione longobarda, dopo aver convertito il marito AGILULFO, facilitando i rapporti diplomatici con l'IMPERO D'ORIENTE e con il PAPA. Nel 615 Re AGILULFO morì e gli subentrò il figlio ADALOALDO, ancora ragazzino, che venne cacciato alla fine dai LONGOBARDI rimasti fedeli al culto ariano. Nel 636 salì al trono ROTARI, che nel 646 promulgò un EDITTO in lingua latina con le prime leggi scritte, in modo da mitigare le conseguenze della "giustizia fai da te" fino ad allora imperante. Dopo la morte di questo Re, seguì un periodo di contese fra ducati ariani e cattolici per la conquista del trono, fino all'elezione, nel 712, del cattolico LIUTPRANDO che, con pugno di ferro, pose fine alle pretese dei duchi fondando un regno potente, con l'obiettivo di unificare tutta l'Italia estendendo il dominio longobardo ai territori bizantini al centro e al sud Italia, tentando inoltre di conquistare ROMA, ma desistendo in seguito per obbedienza al Papa; anzi, restituì i possedimenti ecclesiastici in Piemonte e donò al pontefice il CASTELLO DI SUTRI come primo territorio di proprietà dello STATO DELLA CHIESA. Nel 749 venne eletto Re ATOLFO; il suo fu un breve regno, durato fino al 756. Al tentativo di ASTOLFO, che aveva un indole guerresca, di conquistare di nuovo Roma e il Lazio, Papa STEFANO II chiamò in aiuto i FRANCHI ottenendo molte vittorie che posero al sicuro Roma e portarono ulteriori possedimenti ecclesiastici che si trasformarono in vere e proprie sedi dello STATO DELLA CHIESA. Nel 756 l'ultimo Re longobardo, DESIDERIO, tentò di pacificarsi con i FRANCHI, dando in spose le proprie figlie ai figli del Re dei FRANCHI, CARLO e CARLOMANNO, ma fu una pace di breve durata; ben presto una delle figlie, ERMENGARDA, data in sposa a CARLO (che diverrà CARLO MAGNO) fu ripudiata dal marito, l'altra rimase vedova. Nel 772 DESIDERIO tentò l'invasione delle terre papali, ma venne rspinto da CARLO MAGNO e suo figlio ADELCHI portato prigioniero in Francia. In seguito, CARLO MAGNO divenne Re dei FRANCHI e dei LONGOBARDI e il resto è noto.
Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli
La costruzione del TEMPIETTO LONGOBARDO di CIVIDALE (Udine), in Borgo Brossana, si fa risalire intorno al 760 d.C. (secondo lo storico dell'arte DECIO GIOSEFFI), oppure intorno all'810 (secondo gli storici dell'arte GIOVANNI LORENZONI e ADRIANO PERONI), innanzitutto per i collegamenti stilistici con la Chiesa di SAN SALVATORE di BRESCIA, il cui completamento viene attribuito a DESIDERIO e CARLO MAGNO. La prima testimonianza scritta del tempietto risale all'11 novembre 830, dove viene definito come "monasterium puellarum quod dicitur Sancte Mariae" (monastero delle fanciulle detto di Santa Maria); infatti ebbe funzione di oratorio del monastero femminile. Una tradizione duecentesca lo fa risalire ai tempi di ASTOLFO, paladino di CARLO MAGNO (742-814), e di sua moglie GISELTRUDE, per volontà dei quali venne costruito, in linea con la suddetta tesi. Il tempietto sorse come cappella palatina, connessa con il palazzo del "gastaldo", o funzionario di corte; è considerato come satellite dell'adiacente chiesa di SAN GIOVANNI EVANGELISTA. La struttura del tempietto è rettangolare, misura 10 metri x 6,24 metri, con aula principale a pianta quadrata, nartece all'ingresso riservato ai fedeli, sagrestia laterale, presbiterio riservato al clero. L'aula quadrata centrale è sormontata da una volta a crociera e i suoi muri esterni sono alti 10,70 metri; in fondo, il presbiterio più basso (5,34 metri), suddiviso da due file di colonne in tre sezioni con volte a botte parallele. L'interno dell'edificio è decorato con fregi a motivi vegetali; colonne e pilastri sono elementi riutilizzati di fattura bizantina, oltre agli elementi più importanti: le splendide statue in gesso a ridosso delle pareti di cui tratteremo ora.
Gli sguardi estasiati delle statue nel Tempietto Longobardo di Cividale
Le 6 statue superstiti all'interno del TEMPIETTO LONGOBARDO (VIII secolo d.C.) probabilmente raffigurano le sante martiri IRENE, CHIONA, AGAPE e SOFIA; altre due figure non sono identificate, ma anche riguardo le prime non vi è riconoscimento sicuro. Le statue, modellate in gesso, sono alte da 1 metro e 90 cm. a 2 metri e sono poste ai lati di un'apertura a tutto sesto, decorata a traforo con motivi geometrici e floreali. Le statue oggi appaiono bianche come il gesso in cui sono modellate, ma in origine erano policrome, come testimoniano le esigue tracce di pigmenti naturali ancora presenti. Fra le mani reggono la corona del martirio e la croce. Due di esse, poste ai lati della finestra, accanto alle colonnine, compiono con le mani un gesto d'invito, sono vestite senza decori ed hanno il capo velato; le altre quattro sono frontali e rivolte all'osservatore, indossano abiti lussuosi e decorati in stile bizantino, hanno acconciature aristocratiche con scriminatura centrale sormontate da corone. I corpi appaiono armoniosi, longilinei e ben proporzionati, anche se i volumi sono appiattiti. Dietro il capo per ognuna si delinea l'aureola. I visi hanno tratti nobili; il naso e la fronte formano una linea continua, senza incavo; il naso è appuntito se visto di profilo, ma di fronte le figure appaiono più naturali e "classiche". Hanno le orecchie traforate; le labbra sono leggermente dischiuse, come in un sussurro; i visi sono ovali ed hanno l'aspetto di giovani fanciulle. Gli occhi, innanzitutto, hanno un 'espressione estatica; appaiono sbarrati, fissi verso l'osservatore e, tuttavia, come assenti; hanno forma affusolata, la pupilla è ritirata come se fossero ammaliate da una grande luce: si tratta di veri e propri capolavori, densi di significato e mistica forza espressiva. L'interno dell'edificio è, inoltre, affrescato con soggetti sacri, ma poche sono le testimonianze pittoriche originarie, ossia risalenti all'epoca della sua costruzione (760 circa), poichè dopo il sisma del 1222 alle pitture antiche si sovrapposero opere del XII e XIII secolo. Fra gli affreschi dell'VIII secolo abbiamo una lunetta con il CRISTO BENEDICENTE fra gli ARCANGELI MICHELE e GABRIELE. Il volto di CRISTO, in particolare, sebbene frammentario, lascia trapelare lineamenti di rara bellezza: viso ovale, naso ben delineato dalla forma anatomica naturale, le labbra, a giudicare dal complesso, anche se scomparse, dovevano seguire il naturalismo dell'intera figura; i capelli sono biondi, con scriminatura centrale; il collo è alto ed elegante, ma il dettaglio migliore è lo sguardo, dai grandi occhi languidi e malinconici che guardano in lontananza, la cui espressione è accentuata dalle ombreggiature sottostanti e dalla linea delle sopracciglia più aperta ai lati; con la mano compie il classico gesto del "mudra" (unione di fuoco spirituale e terra, ossia pollice e anulare).
GLI SGUARDI DEI RITRATTI NEI MOSAICI PALEOCRISTIANI DI AQUILEIA
Per quel che riguarda l'arte paleocristiana, rispetto all'argomento di questo saggio, un'eccellente esempio può essere rappresentato dagli antichi mosaici di AQUILEIA, Friuli. La città di AQUILEIA venne fondata nel 181 a.C. dai ROMANI nel territorio delle tribù celtiche di CARNI e ISTRI; inizialmente abitata da circa 3000 coloni veterani, ebbe la funzione di baluardo strategico e piazzaforte militare per il controllo dell'Italia settentrionale e per pianificare l'espansione transalpina. La BASILICA DI AQUILEIA è fra i più antichi monumenti dell'EPOCA PALEOCRISTIANA; venne edificata dal Vescovo TEODORO all'inizio del IV secolo d.C.; la sua pavimentazione a mosaico è la più grande dell'epoca e si estende per 760 metri quadrati; il complesso è suddiviso in 10 sezioni con raffigurazioni bibliche e simboliche. I mosaici più antichi risalgono al III secolo d.C. e si trovano nella cripta; per una grande porzione vennero distrutti dalle fondamenta del campanile fatto costruire dal Vescovo POPONE di AQUILEIA fra il X e l'XI secolo, perciò molte interessanti figure risultano purtroppo troncate. La basilica si suddivide in AULA NORD, ossia la cripta come struttura più antica; AULA SUD, parallela e connessa alla prima da un'altra costruzione: entrambe colonnate, vennero edificate per volere del Vescovo TEODORO, in carica dal 308 al 319. L'AULA TEODORIANA NORD fu costruita dallo stesso TEODORO. Nell'AULA TEODORIANA SUD vi è il pavimento musivo di 760 mq. AULA POST-TEODORIANA NORD, costruita dal Vescovo FORTUNAZIANO, in carica dal 342 al 370). Le varie ristrutturazioni della basilica vanno dall'epoca romana al Rinascimento. I mosaici della CRIPTA dove si estendono le fondamenta del campanile risalgono ad un'epoca di poco precedente l'EDITTO DI COSTANTINO del 313 e, quindi, si tratta di una edificio adibito al culto cristiano a quei tempi ancora celebrato in clandestinità:
<< La porta laterale dell'aula nord (visibile dalla cripta degli scavi) dà l'esatta sensazione di una chiesa segreta e mascherata. Tutte due le aule furono fatte costruire dal Vescovo Teodoro, per cui il nome di Aule Teodoriane >>. (dal libro "Aquileia", pa.10, 1979, di Mons.LUIGI MARCUZZI, 1922-1995)
La particolarità più importante dei mosaici della CRIPTA è il loro simbolismo di chiara matrice gnostica, con raffigurazioni arcontiche sotto forma di animali che accompagnano il fedele nel percorso di liberazione dell'anima dai legami terreni. I mosaici della basilica, invece, raffigurano anche scene dell'Antico Testamento, come quella del profeta GIONA ingoiato dal mostro marino.
Due mosaici molto interessanti nella CASA di LICURGO e AMBROSIA (fra i resti di una domus scoperti nel 1963) ritraggono due volti di divinità marine, uno femminile e uno maschile, che probabilmente sono gli stessi ritratti dei proprietari di casa in veste mitologica, e ciò si deduce dai tratti alquanto individuali: l'uomo ha capelli verdi con lunghe ciocche ricadenti fino al collo e folta barba, accenna un leggero sorriso; due chele di granchio spuntano dalla testa; gli occhi sono sbarrati ed arcaici nella loro fissità. La figura femminile ha capelli con discriminatura centrale, volto pieno e occhi che guardano verso l'alto; dalla testa spuntano delle alghe marine.
IMMAGINI: i due mosaici della Casa di Licurgo e Ambrosia (Aquileia, Udine) che probabilmente ritraggono gli stessi proprietari in veste di divinità marine. Datazione: II secolo d.C. (Descrizione qui sopra)
Quattro grandi volti a mosaico con volti di atleti risalenti al III secolo d.C., dalla palestra termale di AQUILEIA, alti con tutta la cornice circa due metri, ritraggono dei personaggi reali, con marcate caratteristiche individuali: due uomini alti e prestanti, uno biondo con barba e uno castano senza barba, entrambi portano un'acconciatura orientaleggiante con chignon; i loro sguardi sono estremamente espressivi, così come i volti. In mezzo a loro il ritratto di un uomo anziano, con sguardo assente verso l'alto e con una specie di corona in testa.
IMMAGINI: mosaici con volti d'atleti, provenienti dalla palestra termale romana di Aquileia (Friuli). Ampiezza della cornice: circa 2 metri. Datazione: III secolo d.C. (Descrizione qui sopra)All'interno della BASILICA DI AQUILEIA abbiamo 14 ritratti di donatori, o benefattori della chiesa, larghi circa un metro, racchiusi entro clipei (medaglioni) o in cornici quadrate, in tre dei nove scomparti nei quali è suddivisa la grande pavimentazione musiva. I volti hanno tratti molto individuali e osservano in diverse direzioni: una fanciulla in una cornice circolare, con laticlavio a ricami e volute, guarda timidamente l'osservatore, il suo volto è soave e traquillo, i suoi capelli sono raccolti in una treccia che incorona il capo, o forse si può trattare di una corona d'alloro. Altre immagini di matrone hanno un aspetto più maturo ed hanno lo sguardo più assente rispetto alla prima. Un'immagine, in particolare, colpisce particolarmente per il suo sguardo attonito, quasi sgomento, rivolto verso il basso, con occhi fissi, particolarmente contornati di scuro rispetto alle altre figure femminili del complesso, quasi a volerne esasperare l'espressione; questo effetto non è certo dovuto ad imperizia, dato che i tasselli neri della pupilla avrebbero potuto essere posizionati diversamente, normalizzando lo sguardo; il suo aspetto è quello gracile di una ragazzina, il capo è velato, gli abiti sono dimessi; le labbra sono leggermente rivolte verso il basso:
<< Ciò che colpisce in questa figura di benefattrice dal capo velato e dal vestito dimesso è la grandezza degli occhi e lo sguardo penetrante, quasi a voler manifestare una profonda ricchezza interiore >>. (dal libro "Aquileia", 1979, pag.16, di Mons.Luigi Marcuzzi, 1922-1995)
Più che di ricchezza interiore, però, la figura sembra manifestare una condizione alterata: ma perchè lo sguardo è rivolto verso il basso? Peraltro, la ragazza non indossa ornamenti con simboli o allusioni particolari che possano porre un accento particolare su di lei. Di particolare interesse lo sguardo fiero e distaccato di un personaggio con laticlavio, presente in un gruppo di altre tre figure femminili, che molti sono identificano con l'imperatore stesso, COSTANTINO:
<< Tutte quattro le figure sono rivolte verso il corridoio che dall'aula nord teodoriana immetteva in quella sud. Ci colpisce il ritratto nel tondo in basso a sinistra. L'atteggiamento fiero, rivestito del laticlavio e del pallio ci dicono in modo evidente l'importanza del personaggio e il suo rango, quale pubblico ufficiale. Qualcuno vorrebbe ravvisare la figura dell'Imperatore Costantino, legato da rapporti di simpatia con Aquileia, ma l'altissima stima che i Romani avevano per il loro Imperatore, che mai si sarebbe trovato ad essere raffigurato su un pavimento, dove si è obbligati a calpestarlo, sconsigliano di avallare una tale ipotesi >>.
(dal libro "Aquileia", 1979, pag.16, di Mons.LUIGI MARCUZZI, 1922-1995)
Non si hanno indizi sull'identità dei personaggi ritratti sulla pavimentazione della basilica di AQUILEIA, definiti genericamente come probabili "benefattori" ma, ricollegandoci alla riflessione di Mons.LUIGI MARCUZZI qui sopra, possiamo porci una domanda: se non è lecito pensare che il personaggio di alto rango descritto nel brano possa essere l'Imperatore, per l'ovvia ragione che il suo volto sarebbe stato calpestato, perchè allora il volto di queste persone, sebbene circonfuse di grande dignità, dovrebbe poter essere oltraggiato? Possiamo intuire riguardo a ciò l'intenzione di creare un legame tra cielo e terra, un vero e proprio "riflesso" che pone l'accento sull'assioma "così in cielo come in terra" e, in questo modo, le persone ritratte partecipano all'avvento della beatitudine edenica sulla terra, rappresentata dal complesso musivo della basilica come prefigurazione del Paradiso. I volti di queste persone, che siano benefattori o nobili, sono rivolti al cielo come specchio divino e ne ricevono direttamente l'influsso, come mai potrebbe simbolicamente avvenire se si trovassero su pareti o effigi verticali. Questo potrebbe simboleggiare per questi personaggi l'auspicio della resurrezione. Alla luce di questo concetto, possiamo così supporre che, sì, il ritratto maschile dallo sguardo altero che indossa il laticlavio, potrebbe essere anche l'Imperatore stesso o un alto dignitario.
IMMAGINE: la ragazza dallo sguardo spiritato, fra i 14 ritratti musivi della pavimentazione della basilica paleocristiana di Aquileia (Udine). Larghezza del tondo: circa 1 metro. Datazione: IV secolo d.C. (Descrizione nel capitolo qui sopra)
IMMAGINE: ritratto maschile, presunto Imperatore Costantino o alto dignitario, fra i 14 ritratti musivi della pavimentazione nella basilica paleocristiana di Aquileia (Udine). Datazione: IV secolo d.C. Misure del tondo: circa 1 metro di larghezza. (Descrizione nel capitolo qui sopra)
IL MITO GRECO DEL GIGANTE ARGO DAI CENTO OCCHI
IMMAGINE: Stamnos attico a figure rosse con raffigurazione di Hermes che uccide Argos Panoptes, inizi del V secolo a.C., attribuito al pittore di Argos (Kunsthistorisches Museum, Vienna). Argo era un gigante della mitologia greca, la sua forza era inarrestabile; fu soprannominato "Argo Panoptes" (Argo che tutto vede) ed era dotato di cento occhi. Compì numerose imprese: uccise un satiro che rubava le mandrie, liberò l'Arcadia da un mostro devastatore, uccise la terribile demonessa Echidna. Argo purtroppo finì a sua volta ucciso dal dio Hermes (come nell'immagine) su ordine di Zeus, allo scopo di liberare la ninfa Io posta sotto la sorveglianza del gigante. La raffigurazione di molti occhi può avere un significato dispersivo, di conoscenza orizzontale ed esclusivamente mondana, oppure, nel caso del gigante Argo, di onnipresenza e onniveggenza, con la possibilità di conoscere ogni aspetto della realtà. Questo archetipo è connesso ai molti occhi raffigurati sulle ali dei Serafini della tradizione biblica.GLI SGUARDI APOTROPAICI SULLE COPPE GRECHE
IMMAGINE: Kylix (coppa per bere) di terracotta a figure nere con immagine apotropaica di occhi circolari a cerchi concentrici, una figura maschile al centro e due figure femminili ai lati. Grecia Classica.. Dimensioni: 12,6 centimetri di diametro. Datazione: 520 a.C. Questo è uno degli innumerevoli esemplari di kylix con figura di grandi occhi che osservano direttamente colui che sta di fronte al bevitore mentre quest'ultimo porta la coppa alle labbra. Il significato è chiaro: gli occhi dell'osservatore vengono rapiti dallo sguardo ipnotico sulla coppa ed eventuali influssi malevoli vengono deviati e rimandati al mittente.GLI OCCHI IN PASTA VITREA DELLE STATUE DELL'ANTICHITA' CLASSICA
IMMAGINE: gli occhi in pasta vitrea della statua in bronzo di un giovane (340-330 aC.) Trovato nel 1990 sul fondo del mare al largo di Antikythera, a sud del Peloponneso, insieme a molte altre statue di marmo. Grandezza naturale.
IMMAGINE: Testa in pietra di una statua che probabilmente raffigura la dea Afrodite. Scoperta nel 1857 nell’Odeion di Erode Atticus, presso l’Acropoli di Atene. Forse si tratta di una copia di un’opera criselefantina del V o IV secolo. a.C.
CONCLUSIONE
Il modo in cui vennero rappresentati gli occhi nelle raffigurazioni artistiche nel corso dei millenni è da sempre stato connesso alla natura dualistica della realtà: gli occhi delle divinità, nell'iconografia sacra, possono essere terribili o rassicuranti, possono essere occhi di divinità protettrici o di entità distruttive, perciò non fu mai casuale, soprattutto nell'arte arcaica, il colore, la forma e l'espressione scelti. Nel PALEOLITICO SUPERIORE abbiamo anche statuette e figure antropomorfe, come quelle d'avorio di mammut di MALTA-BURET (Russia, datate 20.000 anni) in cui lo sguardo, al di là della corrosione del tempo, doveva apparire molto enfatizzato, con statuette femminili, e alcune altre maschili, dagli occhi molto grandi. Nell'Europa Occidentale, al contrario, le statuette paleolitiche si presentano prive di volto, ma occhi grandi e ben delineati li possiamo trovare nei ritratti incisi su placchette di scisto della grotta di LA MARCHE, delle CHANNEL ISLAND, e in molte altre raffigurazioni. In particolare, un interessantissimo manufatto d'avorio di mammut scoperto nella grotta di CHAFFAUD, Francia, datato 18.000 anni circa, con la figura di un orco dagli occhi circolari che divora un uomo. In EPOCA NEOLITICA (9.000-3000 a.C.) e PROTOSTORICA (2.700-1.700 a.C.) abbiamo una grande accentuazione dello sguardo nelle raffigurazioni votive e nelle sculture. Nell'ETA' STORICA ARCAICA gli occhi vennero ad assumere un significato simbolico sempre più complesso, con analoghe rappresentazioni e significati presso tutte le culture del mondo. In EPOCA CLASSICA (510 circa a.C.), con lo sviluppo di figure umane assolutamente realistiche e misurate nella loro espressione, come esige l'equilibrio e la moderazione espressiva del nuovo paradigma greco, il significato simbolico dello sguardo viene confinato a figure archetipiche, come quella di MEDUSA, e a raffigurazioni puramente simboliche di occhi stilizzati su coppe e altre ceramiche dal valore apotropaico. In EPOCA PALEOCRISTIANA e soprattutto BIZANTINA (dal 400 d.C.) gli occhi e lo sguardo, a volte considerevolmente dilatato, vengono ad assumere una notevole accentuazione, allo scopo di amplificare il sentimento di devozione e ricchezza interiore dei personaggi, che siano essi figure sacre, santi o imperatori. Ma come gli occhi simboleggiano la dualità nella sua forma separativa (sguardi differenziati fra i diversi soggetti, che esprimono sentimenti opposti), così si trasformano in mezzo espressivo di convergenza con il divino negli sguardi fissi ed alterati delle figure sumere e nei grandi occhi dei personaggi nei mosaici bizantini. Si può descrivere gli occhi come traduzione esteriore di una forza interiore, ossia del nucleo stesso dell'essenza, o sole interiore. Si può riassumere brevemente così: i DUE OCCHI della normalità rappresentano l'equilibrio fra le due sfere opposte e complementari della mente, ossia quella intuitiva e quella razionale; TRE OCCHI, ossia l'OCCHIO FRONTALE o TERZO OCCHIO e i due occhi normali, rappresentano il raggiungmento di una conciliazione ad un livello superiore di coscienza, connesso con il potere creativo e chiaroveggente; UN SOLO OCCHIO (MONOCOLO), come quello dei CICLOPI, rappresenta le forze grezze e primordiali, che possono essere rozze, crudeli ma ingenue e, dunque, pure e prive di colpa nella loro essenza; MOLTI OCCHI sparsi ovunque sul corpo, come quelli del gigante ARGO, possono indicare, ricollegandomi al brano qui sopra di CIRLOT e aggiungendovi la mia riflessione, anche una complessità interiore, nel campo della conoscenza, mai elaborata fino al raggiungimento di una connessione con il divino, o intelligenza universale, permanendo in una dimensione di espansione orizzontale, terrena e materiale senza le qualità necessarie all'elevazione spirituale. Gli occhi esprimono una vasta gamma di significati; incarnanao soprattutto la forma esteriore di un mondo interiore, invisibile ed irraggiungibile ai sensi ordinari, giacchè il senso della vista si può espandere, ampliare e potenziare, in base al livello di consapevolezza raggiunto, fino a cogliere dettagli e messaggi della realtà che, in una condizione limitata, non potrebbero emergere. In base a ciò, ecco che gli occhi assumono la funzione di un portale dimensionale, non per l'accesso a dimensioni ultraterrene (questo avviene ad occhi chiusi o in stati alterati di coscienza), ma per la realizzazione stessa di una nuova realtà, più ampia, più complessa e più profonda; questo deve avvenire progressivamente, seguendo lo sviluppo della coscienza, così che gli occhi, presi "per mano" dalla consapevolezza, riescano ad individuare dettagli del mondo reale fino a quel momento rimasti oscuri. Infatti è così: la dimensione a cui siamo legati non è una trappola da cui fuggire, un mondo da conoscere e poi abbandonare (per dirla alla maniera gnostica), ma una struttura senza limiti della cui edificazione siamo responsabili. Prendiamo ad esempio qualsiasi altro tipo di animale fino agli insetti: noi li vediamo e interagiamo con loro, tuttavia essi vivono un'altra dimensione, non vedono ciò che vede un qualsiasi essere umano; pur avendo una vista anche molto più potente della nostra (come l'aquila) non possiedono la consapevolezza necessaria all'individuazione dei dettagli più profondi della realtà; un'ape vede l'apicoltore percependolo come un'enorme massa informe, ma non lo può "individuare", o riconoscere; così come la realtà percepita da un felino, non è la stessa che percepiscono gli uccelli; quella che percepiscono gli uccelli non è la stessa che percepiscono gli insetti ed ogni essere vivente, pur essendo dotato di vista molto acuta, e pur interagendo con gli altri esseri, vive in una diversa dimensione del mondo reale, a seconda delle forze da cui è guidato. Lo stesso concetto può essere applicato riguardo le varie tipologie umane: prendiamo un individuo medio, non ha di certo la stessa percezione della realtà di un artista, di un grande filosofo, ecc...così come questi non hanno la stessa percezione della realtà di un illuminato, di un CRISTO o di un BUDDHA. Pur muovendosi nello stesso spazio, ogni individuo rappresenta un universo a sè stante ed esiste in una dimensione diversa e separata. Gli occhi, infatti, sono strumento di connessione, ma in primo luogo di espansione dell'anima e della coscienza; noi non vediamo con gli occhi, ma con la mente e, ancor di più, con l'anima, attraverso la capacità di percezione che abbiamo raggiunto. Ci possiamo trovare porta a porta con il nostro vicino di casa, ma essere lontani anni luce, come se abitassimo in due galassie distanti e governate da altre leggi cosmiche; così come possiamo essere lontani migliaia di chilometri da persone a noi affini, eppure essere vicine come se la distanza non esistesse, sorvolando gli intricati sentieri della coscienza collettiva. Il senso della vista dell'uomo comune è guidato dall'opinione, egli perciò non vede nulla realmente perchè non ha la facoltà della percezione interiore, tutto ciò che dimostra di apprezzare e che a lui pare bello o brutto è in realtà frutto di un'induzione esterna; l'uomo spiritualmente realizzato, al contrario, possiede una visione autentica di tutte le cose, percependole nella loro intima essenza e reale valore, a prescindere da ogni pregiudizio o costrutto mentale; entrambi camminano su questo pianeta e i loro corpi fendono la stessa aria ma, al contempo, abitano in universi talmente distanti fra loro da non potersi mai incontrare e, pur avendo occhi e vista acuta, l'individuo mediocre non si accorgerà mai della presenza di un uomo dalle qualità straordinarie o dall'animo profondo, ne vedrà la sagoma, come di tutte le altre cose, ma non lo riconoscerà mai, non avendo la facoltà dell'individuazione e, men che meno, della percezione, ed è proprio quest'ultima che vuole essere rappresentata dai grandi occhi delle raffigurazioni arcaiche e tardo-antiche. Vedere significa conoscere, ma soprattutto "espandere", "creare" nuovi mondi, realtà più pure e superiori, dunque non corrisponde ad una facoltà passiva. Nell'ultimo secolo, con lo sviluppo della FISICA QUANTISTICA, abbiamo scoperto molti millenni più tardi rispetto agli antichi maestri, che la realtà non possiede un'esistenza concreta, ma dipende in tutto dal richiamo dell'osservatore. In conclusione, come l'universo e tutto ciò che contiene emerge dall'osservazione di un'intelligenza infinitamente superiore a noi (vedi l'occhio nel triangolo della Provvidenza), allo stesso modo, su scala minore, la nostra realtà è condizionata dall'influsso della coscienza collettiva ed individuale. La rappresentazione degli occhi può essere connessa alla sfera dell'intelletto (realtà), a quella emotiva del cuore e a quella spirituale del TERZO OCCHIO, che corrisponde alla "Via di Mezzo" indicata dal BUDDHA, ossia la saggezza che si trova in mezzo a due estremi; questo è anche il significato dell'occhio racchiuso nel triangolo che rappresenta la TRINITA' divina.
Alessia Birri, 19 giugno 2024
ARTICOLI CORRELATI:
ODINO-ENCICLOPEDIA TRECCANI:
https://www.treccani.it/enciclopedia/odino/
BUSTO DI NEFERTITI - WIKIPEDIA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Busto_di_Nefertiti
PALEOLITICO SUPERIORE - LE IMMAGINI SVELATE- antologia:
https://alessia-birri.blogspot.com/2022/09/paleolitico-superiore-le-immagini.html
I FENICI E LA DIFFUSIONE DEI GIOIELLI IN VETRO:
https://silviafini.wordpress.com/2015/02/24/i-fenici-e-la-diffusione-dei-gioielli-in-vetro/
IL CULTO DELL'OCCHIO DIVINO DI TELL BRAK:
https://archeoworld.com/il-culto-dellocchio-divino/
LE ANTICHE STATUETTE DOGU GIAPPONESI:
https://it.wikipedia.org/wiki/Dog%C5%AB
STATUA DEL RE-SACERDOTE DI MOHENJO-DARO:
https://en.wikipedia.org/wiki/Priest-King_(sculpture)
STATUETTE DEGLI ORANTI DELLA CIVILTA' SUMERA:
https://www.storieparallele.it/le-statuette-degli-oranti/#:~:text=Le%20statuette%20erano%20state%20seppellite,e%20due%20di%20sesso%20femminile.
PRATICHE CULTUALI NEL MONDO EGEO - ENCICLOPEDIA TRECCANI:
https://www.treccani.it/enciclopedia/l-archeologia-delle-pratiche-cultuali-mondo-egeo_(Il-Mondo-dell'Archeologia)/
RITRATTI DEL FAYYUM - WIKIPEDIA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritratti_del_Fayyum
ARTE COPTA - WIKIPEDIA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_copta
ARTE GRECO-BUDDISTA:
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_greco-buddista
ICONOGRAFIA PRE-BIZANTINA, BIZANTINA E POST-BIZANTINA-PDF-314 pagine:
https://www.iconecristiane.it/wp-content/uploads/2020/12/Iconografia_Prebizantina_Bizantina_e_PostbizantinaDomenico-FormatoR.pdf
LA BASILICA PATRIARCALE DI AQUILEIA:
https://www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/aquileia-ud-la-basilica-patriarcale/
IL MITO DI MEDUSA COME POTENTE RACCONTO DI TRASFORMAZIONE:
https://www.eticamente.net/71307/il-mito-di-medusa-e-un-potente-racconto-di-trasformazione.html
IL TEMPIETTO LONGOBARDO A CIVIDALE DEL FRIULI:
https://www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/cividale-del-friuli-ud-tempietto-longobardo/





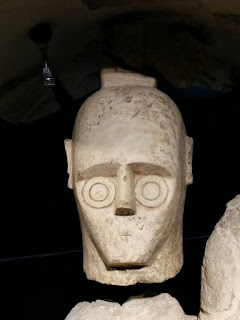









.png)
.png)
.png)




.jpg)

.jpg)






















.jpg)











.jpg)
















.jpg)

























Nessun commento:
Posta un commento